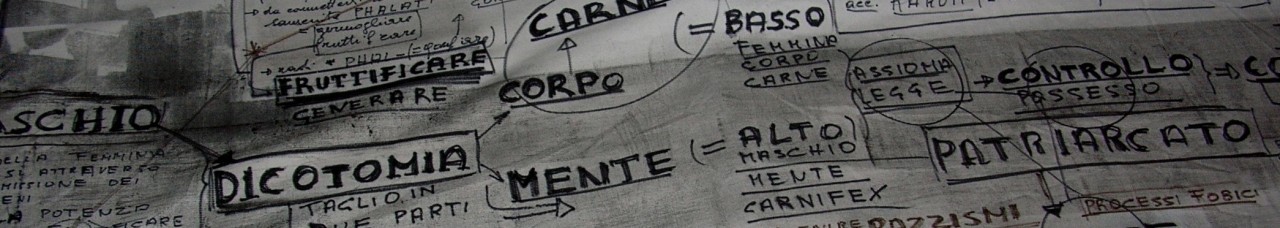di Paola Zaretti/Il Silenzio sulla Nascita e la vocazione maschile per la Morte
di Paola Zaretti/Il Silenzio sulla Nascita e la vocazione maschile per la Morte
– Qual è stato e qual è l’atteggiamento del femminismo, in generale, nei confronti dei temi del materno e della nascita?
– In che misura la teorizzazione del primato di un ordine simbolico materno può essere considerata una risposta adeguata a tale atteggiamento?
– E l’”inclinazione” materna di cui parla Cavarero in Inclinazioni facendo esplicito riferimento al matriarcato e al mitico tempo delle madri, quell’inclinazione che “potrebbe funzionare”:
“come modulo dirompente di una diversa più rivoluzionaria geometria finalizzata a ripensare il nucleo della comunità”
ha qualcosa a che fare con la teorizzazione di un ordine simbolico materno o prelude a uno scenario diverso? La domanda è lecita se si pensa all’uscita di Cavarero dalla comunità di Diotima di cui pure era stata fondatrice. Sono molte e complesse e interconnesse le questioni che ci poniamo, intenzionate a saperne di più e ad approfondire almeno in parte l’argomento, coadiuvate dalle riflessioni di due eminenti figure del femminismo: una teologa femminista protestante, Ina Praetorius, che affronta il tema della nascita, in un capitolo del suo libro Penelope Penelope a Davos intitolato Seguire la traccia della dipendenza. Ovvero che cosa significa essere partoriti? e di una filosofa della differenza, Adriana Cavarero, che http://femminismoinstrada.altervista.org/femina-erecta-approfittiamodelmaterno/, che con il suo ultimo libro Inclinazioni. Critica della rettitudine di cui siamo già in parte occupate, rimette al centro della sua indagine speculativa il tema arendtiano della natalità a lei caro, per proporci, attraverso l’uso spregiudicato dello stereotipo oblativo materno veicolato dal patriarcato, un progetto di “transvalutazione” del materno.
L’esigenza di riconsiderare, a nostra volta, l’atteggiamento del femminismo nei riguardi del materno e del tema della natalità, è nata anche a seguito del nostro impegno e delle energie impiegate nel blog, che ci hanno indotte a meditare sulle nostre scelte e sul successo decisamente modesto accordato dalle frequentatrici di Tabula rasa a una pagina volutamente dedicata al materno e felicemente intitolata da Emanuela Borrelli Stato interessante. http://femminismoinstrada.altervista.org/stato-interessante-3/.
Perché le femministe sono così poco interessate a Stato interessante? – ci siamo chieste. Qual è la ragione di questa evidente presa di distanza, quasi un tabù, da ciò che concerne la sfera del materno e come si accorda questa postura, questa presa distanza – che ha tutta l’apparenza di una “resistenza” – con il desiderio, indubbiamente interessato, che ha portato delle donne ad accogliere, in passato, la teorizzazione di un ordine simbolico materno al punto di farne una pratica di “cura dell’isteria” all’interno di tale ordine? Non che ci aspettassimo, ingenuamente, una smisurata attenzione. Sappiamo bene, infatti, che il materno – e la smorfia che generalmente accompagna l’immaginario negativo costruito attorno ad esso – continua ad essere per molte femministe, e per delle comprensibili ragioni, una specie di tabù che ingombra, intralcia, impedisce, oscura, riduce e tradisce quell’essere donna della donna che la cultura patriarcale ha sacrificato in nome del primato materno e dell’inclusione della donna nella madre. Sappiamo anche che il sacrosanto rifiuto di tale inclusione e dell’oscuramento che soggettivamente ne deriva, ha finito per attivare la ricerca di una pseudosoluzione – il ribaltamento del primato della donna sulla madre – riproponendo così, in termini rovesciati, la stessa opposizione binaria donna-madre i cui effetti traspaiono nel linguaggio, nel rigetto, di certe parole (cura) a favore di altre (relazione) ritenute meno “contaminate” con il maternage, non senza l’inevitabile confusione che da tutti questi sintomatici “distinguo” può nascere, per lo stesso femminismo, in termini di intellegibilità.
A partire dalle domande formulate all’inizio siamo dunque intenzionate ad avviare una prima indagine – certamente parziale trattandosi di questioni davvero scottanti – sulla presa di distanza e sull’imbarazzante silenzio del femminismo nei riguardi della nascita – e della relazione di dipendenza che essa inevitabilmente comporta – chiedendoci se questa distanza e questo silenzio derivino da una postura analoga a quella “verticalizzante” che Cavarero attribuisce nel suo libro ai teologi e ai filosofi e che viene da Preatorius così immortalata:
“La paura della madre divorante potrebbe essere un ulteriore motivo del singolare silenzio con cui i filosofi coprono la nascita. Chi vada in cerca di questo lemma, nascita, nei dizionari di filosofia o di teologia non trova quasi niente. In una famosa enciclopedia teologica, per esempio, si possono leggere cinquantanove pagine che riguardano la morte, ma nemmeno una riga sulla nascita. Un altro testo di teologia, Die Religion in Geschichte uns Gegenwart, dedica alla nascita più o meno una colonna e mezza a fronte di tredici dedicate alla morte”.
Di qui il matricidio originario che, secondo Irigaray, segna l’inizio della storia dell’Occidente. Praetorius si chiede, naturalmente, quali possano essere le conseguenze su di noi di una visione così negativa della nascita, che cosa significhi insomma, per noi, essere abituati, da secoli, a pensare noi stessi più a partire dalla mortalità che dalla nascita, un evento cui assegna in queste righe – come Arendt ma diversamente da lei – un posto di tutto rispetto:
“Ciò che vediamo è una piccola creatura coperta di sangue e muco, la pelle raggrinzita e bluastra, che esce, spesso con enorme fatica, dal corpo di una donna”.
A dire, insomma, che “nessuna persona” “si è fatta da sé” ma viene al mondo, attraverso il parto, attraverso una relazione che ci rende per tutta la vita dipendenti dall’altro in cui rimane “collocata la nostra libertà”. Di qui la domanda successiva e un nuovo riferimento critico di Praetorius ai filosofi, in particolare a Kant – che non verrà risparmiato neppure da Cavarero – e al loro ostinato silenzio sull’origine:
“Ma l’esser partorito è un benedizione o una condanna? Ciascuno può affermarlo soltanto per se stesso. Ciò che non possiamo decidere è se vogliamo essere messi al mondo oppure no. Questa eteronomia del nostro inizio, l’”imposizione” della nascita è forse il motivo che ha indotto un grandissimo numero di filosofi, soprattutto dell’illuminismo, a considerare la propria origine con rabbia, riluttanza, addirittura trincerandosi dietro il silenzio. Immanuel Kant ha interpretato il primo grido del neonato come una protesta contro l’eteronomia dell’inizio”.
Non potevano naturalmente mancare dal ricco repertorio di Praetorius, il celebre riferimento biblico alla maledizione rivolta da Giobbe al giorno della sua nascita e il riferimento letterario a un significativo passaggio tratto dal romanzo La ripetizione di Peter Handke di cui riportiamo, per brevità, solo gli estremi:
“Una volta la mamma mi ha raccontato i momenti della mia nascita (….). La mamma voleva forse farmi contento con il suo racconto, ma io fui preso dal terrore, come se si parlasse, non della mia nascita, ma della mia morte”.
La descrizione del terrore della nascita – un terrore comune a teologi e filosofi – ci riporta alla nostra domanda iniziale che può essere ora così riformulata: in quale misura la categoria arendtiana della nascita, tenuta in sommo dispregio da questi esimi rappresentanti del genere maschio, è stata apprezzata e tenuta nella giusta considerazione dal pensiero femminista della differenza? Possiamo affermare l’esistenza, su questo aspetto, di una “differenza”, o c’è qualcosa, un certo disinteresse, un certo pregiudizio che accomuna il pensiero femminista sulla nascita al pensiero di quei filosofi e teologi cui Praetorius e Cavarero fanno riferimento, al loro ostinato e sintomatico silenzio, alla loro inclinazione per la morte, alla riluttanza e alla rabbia legata all’origine in diversi modi teorizzata? E se così fosse, da che cosa potrebbe dipendere? Da una mancata esperienza di maternità che porterà Cavarero ad azzardare un parallelo fra la sua amata Arendt e il filosofo di Konigsberg il cui io “verticale” rappresenta, nella storia del soggetto, un “caso esemplare”?
L’interrogativo non avrebbe ragione di essere posto, se non fosse che nell’attuale dibattito femminista emancipazionista e post-strutturalista c’è un’accusa precisa che viene mossa al paradigma dell’”etica della cura” – nel cui ambito l’evento inaugurale della nascita si colloca a giusto titolo – relativa al fatto che l’assunzione di tale paradigma andrebbe a rafforzare, di fatto, il sistema binario patriarcale. Di Kant e del suo orrore per la nascita e per la miserevole condizione di dipendenza dell’infante, ci parla, del resto, anche Adriana Cavarero nel suo ultimo libro Inclinazioni. Critica della rettitudine. Lo fa attraverso un passaggio piuttosto singolare – che ho già in parte anticipato – in cui la sua pur amata Arendt, nei riguardi del cui pensiero si dichiara debitrice, viene accostata, almeno per un aspetto, a Kant:
“Sposata per ben due volte, ma senza figli, forse Arendt, come Kant, non ama né le mamme né le balie né i bambini. Evita così di cimentarsi con lo stereotipo della maternità. Come giova ripetere, non sempre, però, gli stereotipi sono un mero ingombro al lucido lavoro della riflessione. Alcuni, come quello legato alla figura materna, conservano, anzi, una grande potenzialità critica che vale la pena di scovare e far fruttare (…)”.
Su questa grande potenzialità critica dello stereotipo del materno da “far fruttare”, Cavarero ritorna a più riprese nel testo ma ciò che qui interessa rilevare è la sottolineatura dell’intimo legame esistente tra una teoria e il soggetto che la genera. Come dire le nostre teorie sono il risultato di ciò che noi siamo, pensiamo, facciamo, viviamo, il frutto, insomma, di un “mescolarsi degli impulsi tra loro”. (Nietzsche). Detto altrimenti, è la particolare condizione soggettiva di Harendt – la sua storia e il suo vissuto esperienziale di donna senza figli, simile, in questo e solo in questo, a quello del filosofo di Konisberg – a decidere della materia della stoffa e della piega presa dalla sua teoria e a rendere impossibile a lei, non madre, di “cimentarsi con lo stereotipo della maternità” nonostante e a dispetto del primato da lei assegnato alla natalità. Inutile dire che il parallelo fra Arendt e Kant, fautore di un soggetto “autosufficiente” e “autoreferenziale”, “radicalmente autonomo” e “chiuso in sé”, “verticale e diritto”, non fa onore alla nostra filosofa alla quale Cavarero non risparmia un’amorevole critica quando rileva che, paradossalmente, proprio la filosofa che ha fatto della nascita “la categoria fondamentale dell’ontologia e un tema essenziale della politica” e che in nome di tale categoria si è opposta al pensiero filosofico tradizionale centrato sulla morte, non se ne è infine discostata nel momento in cui il neonato da lei messo in scena è un neonato, per le ragioni suddette, orfano di madre, un neonato insomma che:
“chiamato a incarnare miracolosamente il miracolo dell’inizio, sembra consumarsi nell’istante di questo compito esemplare, rischiando così di rimanere tale per sempre senza mai assumere le sembianze del bambino o dell’infante”.
La rappresentazione della natalità che Arendt mette in scena è un quadro del tutto astratto:
“un quadro algido e poco credibile, quasi un omaggio al vecchio vizio filosofico di sacrificare la complessità del mondo reale alla purezza del concetto”.
Ciò che in nome della purezza del concetto il quadro “algido e poco credibile” non contempla non è dunque la sfera della ratio ma la sfera dell’affetto e delle passioni la sfera di quell’inclinazione verso l’infans che Harendt, come lo scapolo Kant, non può, per analoghe ragioni, sostenere. Ciò non toglie che sia stata Arend proprio lei, ad aver assegnato alla nascita un posto d’onore, ad aver inaugurato un nuovo territorio tutto da dissodare la cui esplorazione resta, tuttavia, secondo Cavarero, particolarmente difficile per via della censura messa in atto dal pensiero femminista nei riguardi di un materno “inclinato” che comporta il rischio di rafforzamento di “una lettura biopolitica del lavoro femminile di cura” rilevato già a suo tempo da Putino. Scrive infatti Cavarero:
“Per quanto riguarda il paradigma specifico dell’etica della cura nel dibattito attuale, l’accusa che frequentemente gli viene mossa – non solo dal femminismo emancipazionista ma anche da quello di ispirazione post-strutturalista – è di nuovo che il modello finisce per consolidare l’economia binaria patriarcale, confermando il ruolo oblativo e sacrificale attribuito alle donne. Pur sottratto alla marginalità dell’ambito domestico e caricato di una dignità di portata potenzialmente universale, lo stereotipo della maternità – questa, in sostanza, l’accusa – riceve, anche nel caso dell’etica della cura, un indebito e ulteriore accreditamento. Se pur cambiano le epoche e gli stili concettuali interni agli sviluppi della polemica femminista, l’argomento è dunque sempre lo stesso: quando l’esercizio di pensare la relazionalità umana in termini di vulnerabilità e dipendenza va a coinvolgere la figura materna, scatta immancabilmente l’accusa di rinforzare l’immagine patriarcale della donna, imponendo di rinunciare all’operazione. Ciò vale a tutto campo, compreso l’attuale e frastagliato arcipelago di studi che, rielaborando in vari modi la lezione di Gilligan ed estendendola all’ambito politico, si sforza ancora una volta di rendere complementare il paradigma relazionale della cura con quello individualista dell’autonomia, nel tentativo di pensare una soggettività, disinnescata dalla trappola del gender, in cui ambedue gli orientamenti, invece di contrapporsi, si temperano a vicenda.
L’argomento su cui la polemica femminista non tace è dunque – come viene qui rilevato – “sempre lo stesso”. E’ una frase che sconcerta e preoccupa per l’allusione critica a una certa ripetitività, a una forma di rigor mortis di un pensiero che resiste al cambiamento, come se nulla di considerevole ci fosse più da pensare, come se tutto fosse già stato pensato. Il brano citato, tratto da Inclinazioni, ci indica una via per comprendere quanto sia facile pensare che basti distruggere uno stereotipo per liberarsene e per considerarsi immuni dal rischio, sempre in agguato, di indossare la camicia di forza di un altro. Così, il giusto rifiuto di identificare il femminile con il materno nei termini in cui tale identificazione è stata pensata dal patriarcato – in termini di relazionalità, di vulnerabilità e dipendenza e di sacrificio – finisce per portare alla costruzione di un modello di Femina erecta, di un paradigma di donna invulnerabile, indipendente, autonoma, autarchica e sovrana la cui postura finisce per essere più confacente al paradigma di un’ontologia individualista maschile che a un’ontologia della relazione. Inutile dire che se la parcella richiesta a una donna per il riscatto dallo stereotipo del materno dovesse essere così alta, sarebbe per lei una rovina. Non è forse di questo rischio che raccontano i vari tentativi femministi di uscire dall’opposizione attraverso la “conciliazione” degli opposti e il ricorso alla “complementarietà” di cui Cavarero dà conto qui come altrove (Le Filosofie femministe) evidenziando i limiti di un’ operazione decisamente poco raccomandabile?
Per concludere e per avere un quadro di quanto sia ancora vivo e presente in ambito femminista il terrore fobico di risucchio della donna nello stereotipo materno, basta leggere il Report della discussione svoltasi alla presenza di Ina Praetorius all’Agorà del Lavoro di Milano il 27 gennaio scorso, in cui la sua focalizzazione sul primato della nascita viene fortemente ridimensionata come se la nascita – e la cura come dono incondizionato ad essa legato – rappresentassero per il femminismo il pericolo di “cancellare la presenza forte delle donne e del loro desiderio” e la loro “soggettività politica”. “Presenza forte”, “desiderio”, “soggettività politica”, vengono dunque rivendicati e considerati, all’interno della gerarchia valoriale femminista, al primo posto. E non sorprende, considerata la visione di Praetorius, che la sua risposta a fronte di un utilizzo rituale di certe parole d’ordine femministe che poco inclinano alla cura e al dono “incondizionato” che essa comporta, sia stata tanto secca e perentoria da dissuadere da una replica:
“C’è un aspetto di incondizionato perché il bambino se non riceve la cura muore. Così come tutti abbiamo bisogno dell’ossigeno per vivere”.
Una certa distanza dalla posizione di Praetorius – in particolare da quel legame fra nascita e cura che chiama inevitabilmente in causa il materno – risulta evidente anche in altri interventi tendenti a ridimensionare la portata di tale legame. A darci la misura – al di là di ogni tentativo riduzionista banalizzante – dell’ampiezza di ciò che Pretorius intende per cura, basti pensare che “ogni lavoro” deve essere per lei “un lavoro di cura”, sia che si tratti della produzione di una macchina, della cura a un giardino o di quella di un bambino. Eppure pare che a far problema, in quel contesto, sia stata proprio, e ancora, un certo fastidio per la parola “cura” cui si preferisce il termine “relazione” – come se una relazione senza cura della relazione stessa, fosse davvero pensabile. Le parole di Praetorius sono due: dipendenza e relazione. E poiché a far problema nella parola “cura” è proprio l’idea di dipendenza, vorrei chiudere regalando a chi legge, uno dei passaggi più belli di Cavarero ricavato da un suo dialogo con Butler:
“Non ritengo che la relazione di dipendenza sfoci necessariamente in un’ansia di indistinzione che è coestensiva alla vita. Vedo piuttosto il pericolo che il sogno vecchio e moderno, dell’autonomia del sé, scambi la relazione per indistinzione e la dipendenza per incorporazione. Detto altrimenti, le patologie egocentriche del soggetto moderno o, se vuoi, dell’ontologia individualista, mi preoccupano molto di più delle sue ansie – alquanto coerenti – nei confronti dell’altro in quanto luogo di contaminazione, disfacimento, dissoluzione. Perché dal punto di vista della storia della filosofia occidentale, se ci pensi bene, c’è appunto una certa logica nella follia di questo “soggetto” che, dopo secoli spesi a celebrare la sua autonomia e autopoiesi, non appena scopre a dipendenza, viene colto dal timore di sparire nell’altro”.