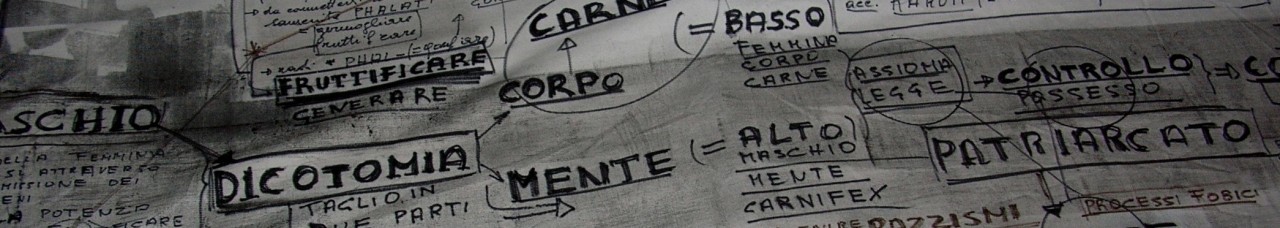Care Cassandre, Convegno Gorizia 2008 con Slavoj Zizek
Intervento di Paola Zaretti Il furto del femminile e le traversie del materno
Buon giorno e grazie per l’attenzione. Un ringraziamento speciale ad Alberto Princis per avermi invitata a partecipare a questo momento culturalmente intenso che si svolge in una città dalla quale le mie origini non sono lontane. Mi spiace davvero non aver potuto prender parte agli eventi significativi e sicuramente entusiasmanti di queste giornate i cui effetti energetici si faranno di certo sentire sul desiderio di ciascuno/a che, dopo iniziative di questo genere, ripete sempre… Ancora.
Ed è da questo Ancora, da questo Encore – che è anche il titolo di un famoso Seminario di Jacques Lacan, uno psicanalista francese molto conosciuto in Italia soprattutto negli anni ‘70, che prenderò spunto per il mio intervento. Non fosse altro che per via dello scandalo suscitato a suo tempo da un celebre enunciato inviso alle femministe dell’epoca: anni 70, per intenderci:
Non c’è La donna, articolo definito per designare l’universale. Non c’è La donna perché – ho già arrischiato questo termine e perché dovrei pensarci su due volte? – per essenza elle n’est pas toute.
Lei, la donna, non c’è, non esiste, Lei è non-tutta, ed è per questo che Lacan può dire – ciò che sovente si dice – che le donne sono pazze “ma non pazze del tutto”. Lei “non esiste che come madre” – quoad matrem, affermazione che, almeno nelle intenzioni, non allude a un destino irriducibile ma è una pura e semplice constatazione di uno statu quo della condizione femminile. Verità incontestabili di cui le donne hanno scienza e coacienza e da cui la loro vita è dolorosamente attraversata con gli effetti di scissione e di alienazione che questa non-esistenza al di fuori del materno comporta sulla loro Vita di donne-non-solo-madri:
La donna dando la vita perde la propria (Genesi, capitolo II).
E siamo già, con questi pochi cenni, sulla via per orientarci sulla complessità di alcuni significanti chiave presenti nel titolo e per comprendere che fra donna e madre non c’è identità necessaria, così come non c’è necessaria coincidenza fra donna e femminile – l’esistenza di donne più maschi dei maschi e le squallide insegne del bullo maschio prese a nolo da alcune adolescenti femmine ce lo confermano – e neppure, come sembra ovvio, fra femminilità e maternità. Gli esempi in proposito non mancano – vicini e non.
Per fare un esempio lontano nel tempo riguardo a quest’ultima accoppiata, sappiamo che per tutta la tradizione greca il parto era considerato alla stregua di un combattimento, come la “prova virile più compiuta della donna”. A darcene conferma, sono le parole pronunciare da Medea nella tragedia di Euripide:
Vorrei tre volte trovarmi in prima linea, con lo scudo al fianco, anziché partorire una volta sola.
Come dire, forse, che ”l’acme delle femminilità sarebbe uscire dalla femminilità…?”. Così si interroga Nicole Loreaux, docente alla Scuola degli Alti Studi in Scienze sociali di Parigi ne Il femminile e l’uomo greco. Se mi è concessa una battuta su questo statuto di non esistenza della donna al di fuori della maternità, battuta che nasce da un’esperienza di molti anni di travaglio con le donne – non per via di una scelta separatista, beninteso, ma per la penuria numerica di soggetti di genere maschio disposti a intraprendere un percorso di conoscenza su se stessi – butto là alcuni quesiti:
– Sì, ma per chi? Per chi la donna esiste solo quoad matrem? Per i propri figli ?
– E per esistere e avere un posto riconosciuto in un ordine simbolico a misura d’uomo, è forse sufficiente essere una madre? Una madre single o una madre vedova che posto ha?
– E, ancora, qual è la parte e quanta parte ha l’uomo, all’interno della coppia, nel favorire questa non esistenza della donna in quanto donna e nel concorrere alla limitazione della sua esistenza solo quoad matrem?
L’argomento di cui devo occuparmi mi ha impegnata più di quanto avrei immaginato per l’annodarsi del titolo attorno a tre parole: femminile, materno, donna, che rinviano a un orizzonte epistemico talmente vasto da convocare la storia e la cultura di un’intera civiltà: la civiltà di un Occidente il cui dominio, ha letteralmente fuorcluso dalla storia la metà del genere umano. Quanto basta per desistere dall’impresa di trasmettervi qualcosa di lineare e facilmente tascabile. Farò tuttavia farò del mio meglio cominciando a dire che questa fuorclusione della “razza delle donne” dal sapere, dalla storia, dai luoghi in cui si decide del Vivere e del Morire e che fa dire a Loreaux: “chi non è l’artefice della storia ne subisce le conseguenze”, è la ragione fondamentale di quella che può essere oggi definita, a ragione, una vera e propria guerra di genere fra uomo e donna. Ed è la memoria viva e bruciante di alcune di queste conseguenze, a sollecitarmi, in questa sede, a ritornare su quanto ebbi a dire altrove, ossia che come donna, sono fiera di non essere stata complice, nel tempo concessomi e per quello che mi rimane, di una cultura e di una civiltà dagli esiti distruttivi.
Considerata dunque l’ampiezza e complessità dell’orizzonte epistemico contemplato nel titolo che sottintende la conoscenza dell’apporto storico a questo tema di discipline diverse: antropologia e filosofia, psicanalisi e sociologia, politica e teologia, tratterò del femminile, delle traversie del materno e della donna da inventare, dando priorità e risalto ai contorni di queste tre figure per come esse si disegnano nel contesto storico attuale e inserendo qua e là, altri riferimenti pertinenti al discorso senza la pretesa di realizzare in un tragitto così breve, quel modello d’armonia dii un corpo umano cui, secondo Platone, il corpo ben articolato di uno scritto o di un discorso dovrebbe in tutto e per tutto assomigliare. Ciò richiede che si tengano nel dovuto conto, gli scenari di violenza da cui oggi è segnata, in un vertiginoso crescendo, la relazione uomo-donna e il cui misconoscimento renderebbe impossibile qualsiasi predizione futura sui possibili scenari a venire, sugli sviluppi involutivi, sui destini, insomma, di una relazione fra i sessi che riguarda, in definitiva, la società civile nel suo complesso e l’ umanità tutta intera. Un tale approccio è ineludibile perché nulla, proprio nulla della donna si può dire senza che si dica dell’uomo e viceversa anche se dell’una e dell’altro si possono – e si debbono – dire cose profondamente diverse. Ed è promettente quando a prendere l’iniziativa in tal senso e a esporsi in prima fila, è un soggetto di genere maschio davvero all’altezza che, immune da ogni pregiudizio, riconosce che “il corpo delle donne deve essere castigato per il solo fatto di esistere”, che deve essere “chiuso, recluso, domato e sepolto, prima vivo e poi morto”. O che non esita ad affermare che la criminalità è e resta prerogativa maschile. Ebbene, io credo che questa verità sia tempo di guardarla in faccia ma ritengo anche che il compito e il dovere di farlo – che esige un atto etico e politico radicale – spetti, prima che alle donne, ai rappresentanti di genere maschio delle nostre istituzioni e non: ai padri di figlie, ai figli di madre, ai mariti di mogli, ai fratelli di sorelle stuprate e/o uccise. La salvaguardia della vita delle donne non è solo affar loro, non è una questione da donne o di donne ma è compito in cui dovrebbero sentirsi parte attiva, per primi, i soggetti appartenenti allo stesso genere di coloro che di questa violenza sono gli agenti. Ho dovuto, dopo tanti anni d’esperienza, rassegnarmi all’idea che l’uomo, in generale, sia affetto da una sorta di autismo. Di questo le donne che vengono a trovarmi si lamentano senza accorgersi che ciò che insistono, estenuate, a domandare, è qualcosa che è dell’ordine di un impossibile. Un infaticabile domandare normalmente e volgarmente tradotto, in gergo maschile, come “brontolare”. Di qui la necessità di trattare l’argomento mantenendo vive, sullo sfondo, le ferite di quegli scenari attuali per definire i quali il discusso termine di femminicidio non è improprio. Trattare di femminile, di materno e di donne ignorando l’odierno contesto, mi sembrerebbe riduttivo e persino irrispettoso e dirò di più: non credo nemmeno che in un momento come questo sia la cosa più giusta da fare. E sapete perché? Perché il rischio cui si va incontro – e che vorrei scansare – è quello di trovarsi impantanati per l’ennesima volta nella ripetizione di un cliché consumato, di un dispositivo scenico in cui la donna fa il suo ingresso sempre e ancora nella consueta veste passiva di oggetto di cui si dice, si scrive, si parla, si narra.
Come accade, purtroppo, in questi ultimi decenni anche nella piega ideologica monogenere di una clinica a senso unico, mono-pilotata sulle patologie femminili, il cui guadagno in termini di tornaconto – oltre che economico – è una sempre crescente patologizzazione e discriminazione del femminile a favore di un’ignoranza protetta e sospetta nei confronti delle patologie maschili, oscurate grazie all’impiego, per designarle, del termine “criminalità” che tutte le neutralizza e cancella: “Motivazioni relazionali, attinenti a un desiderio di vendetta o all’incapacità di accettare e di elaborare cognitivamente l’abbandono di una partner”. Così si legge in un passaggio del recente disegno di Legge contro la violenza avallato dai cosiddetti “esperti in materia” E poiché ho introdotto il termine, “passività”, colgo l’occasione per anticipare sin d’ora che solo un salto, una svolta da una posizione femminile vittimista verso una sua trasformazione radicale, può rendere a pieno il senso e il significato – forse un po’misterioso – di quell’ Inventare la donna che si legge nel titolo. In cui si profetizza, o, se volete, si fantastica su un evento a venire quale compimento etico di un progetto di Vita ri-pensato al femminile, secondo quel programma di de-fallicizzazione assai diffuso nel panorama filosofico europeo del XX secolo, sintetizzato in quel pensiero teorizzato soprattutto in Francia da Deleuze, Lacan, Foucault. Derridà e in Italia da – Cacciari, Rella, Vattimo – contro il progetto di morte che la ragione dell’Occidente con il suo immedicabile odio per l’Alterità, la Differenza, la Dualità e la sua passione sconsiderata per l’Uno indifferenziato ha messo in atto sin dalle sue origini.
L’esito di questa operazione di reductio ad Unum è ciò che Jean Baudrillard ha chiamato in uno dei suoi libri, “Lintelligenza del Male” che è l’intelligenza “di una forma duale irriducibile”, e dunque ineliminabile, che è “l’intelligenza segreta della dualità e della reversibilità” resistente ai programmi di “beatificazione universale” dell’Uno, del Tutto, dell’Integrale, dell’Universale.
Tutto ciò che infrange la dualità, che è la regola fondamentale, tutto ciò che aspira a essere integrale porta alla disintegrazione, per risorgenza violenta della dualità. E’ la dualità, sempre liquidata, scongiurata con tutti i mezzi, che viene a restituire un’assenza, un vuoto generalmente sommersi da una presenza totale. E’ la dualità che frantuma la Realtà Integrale, che spezza ogni sistema unitario o totalitario attraverso il vuoto, il crash, i virus, il terrorismo.
A testimoniare di questa “dualità sempre liquidata” e scongiurata con ogni mezzo, a “restituire un’assenza”, a opporre resistenza alla logica dell’uni-verso, del Tutto, contro il di-verso, è la donna – pas toute, non-tutta, non Una – in grado, proprio in virtù di questa sua resistenza e grazie a questa risorsa, di operare un sovvertimento della logica fallocentrica della prestazione, della logica del più e del meno che da sempre abita la storia e la cultura dell’Occidente, mostrando In tutto il’inconsistenza dell’Uno. ln tutto il mondo siamo sempre in due – titola un libro di Irigaray uscito qualche anno fa – e aver “liquidato” questa dualità, averla misconosciuta, è la grande responsabilità storica di un sistema patriarcale votato al suicidio per aver coltivato al suo interno i germi, insomma, della propria dissoluzione. L’espulsione della differenza – e la Differenza uomo-donna è la Madre di tutte le differenze da cui ogni altra discende – messa in atto dalla “bestia patriarcale” – per usare un’espressione cara a Naranjo – porta inevitabilmente all’autodistruzione perché:
Tutte le forze negate, espulse da questo stesso processo, e che divengono con ciò le forze del Male, si ribellano. La potenza stessa si vieta di essere totale, si destituisce, si disinveste, alla fin fine lavora segretamente contro se stessa.
Il Patriarcato muore, si auto “s-termina” non per colpa delle donne ma in ragione del suo autistico ruotare a vuoto su se stesso, e questo avvitamento circolare, questo circolo vizioso – abissalmente distante dal circulus vitiosus deus di nietzschiana memoria – è il prezzo da pagare all’esclusione dal suo Uni-verso di tutto ciò che è Altro da sé, Differente da sé. E per uscirne, non c’è che un modo: amare la Differenza, l’Altro dall’Uno. E se è vero quel che dice Lacan che quando si ama, lo si fa sempre e solo da una posizione femminile – a prescindere dall’anatomia – è questa posizione, odiata e agognata, vilipesa e rubata che uomini e donne devono acquisire con un paziente lavoro individuale di ritessitura di e su se stessi.
E se la psicanalisi non dovesse servire a questo, sarebbe del tutto inutile.
Un lavoro più congeniale alla donna, certo, e non solo per una sua naturale inclinazione a interrogare e a interrogarsi ma anche perché se c’è qualcosa di ontologicamente, fisiologicamente, psicologicamente, eticamente e persino esteticamente estraneo al pluri-verso modo di pensare femminile, questo qualcosa è dell’ordine di un’impossibilità a pensare uni-vocamente, ad assumere il registro lineare e oppositivo instaurato dal patriarcato da cui l’antagonismo di genere e la guerra fra i sessi ha propriamente origine. E sapere questo, conoscere le radici storiche, filosofiche, antropologiche e i presupposti da cui questo antagonismo maschio-femmina è nato e si è andato culturalmente affermando, è essenziale per evitare analisi grossolane e rimedi improbabili.
Valgano, questi pensieri, da preludio a quelle che potrebbero essere, se non delle conclusioni, almeno alcune vie immaginabili in vista di un eventuale mutamento dello stato attuale delle cose. Il difficile passaggio che le donne in generale e il movimento femminile nelle sue punte più avanzate dovrebbero compiere, è ben indicato da ˇZịzek – la cui partecipazione a questa iniziativa mi rende oltremodo piacevole l’opportunità di citarlo – là dove, argomentando della resistenza femminile indica quello che è, a suo giudizio, il modo più efficace, più radicale, per fondarla.
Se la donna è “un sintomo dell’uomo”, un luogo in cui emerge l’antagonismo insito nell’ordine simbolico patriarcale, ciò non limita affatto la portata della resistenza femminista, ma le fornisce al contrario un’esplosività perfino maggiore.
Come dire che il compito delle donne nell’attuale, è uscire dal ghetto rivendicazionista e re-attivo che le inchioda a giocare in difesa. E’ rendere manifesto, trasparente il fatto che l’opposizione al maschile loro imputata è il prodotto inevitabile dell’antagonismo insito nello stesso ordine simbolico patriarcale che di tale antagonismo – di cui è artefice – le accusa. Se tuttavia si postula che sia lo stesso sforzo patriarcale di contenimento e categorizzazione della femminilità a generare forme di resistenza, si apre allora lo spazio per una resistenza femminile che non è più una resistenza in nome del fondamento sottostante, bensì un principio attivo in eccesso rispetto alla forza oppressiva. Di qui la conclusione di Zizek solo in apparenza stravagante:
…) Forse un’autentica affermazione femminista consisterebbe nel proclamare apertamente: “Non esisto in me stessa, sono soltanto l’incarnazione del fantasma dell’Altro.
Non si può non accogliere questo suggerimento, certo provocatorio e paradossale, se non altro perché una tale esplicita enunciazione da parte delle donne, potrebbe dare uno scrollone alla tendenza dei moderni curatori d’anime e a mutare la direzione dei loro interessi – certo più ideologici ed economici che clinici – verso lo studio delle patologie maschili da sistema e delle loro conseguenze nella vita individuale e nel sociale e, come Freud stesso suggeriva ne Il Disagio della civiltà, sullo studio delle nevrosi della collettività. Ho riconosciuto nel linguaggio di Zizek, nella sua insistenza sull’”atto radicale” “femminile”, una profonda affinità con Alain, il Maestro di Simone Weil, là dove chiama col suo vero nome – Giustizia – la vera posta in gioco per Simone – e per le donne tutte, aggiungo io.
Ognuno riconoscerà, in particolare, che l’opinione femminile è un radicalismo dominato da molto in alto dalla Giustizia.
Radicalismo, sì. Ma radicalismo e rivendicazionismo non sono sinonimi, smettiamo dunque di confonderli. E non è nemmeno più tempo di ridurre la passione delle donne per la Giustizia, a una smania riparativa per via di una supposta mancanza: invidia del pene – per intenderci. Anche perché sappiamo bene, da quanto la storia ci ha tramandato, in quale misura il pensiero greco sia stato ossessionato dalle problematiche inerenti la differenza sessuale, in quale misura l’atto procreativo e la gravidanza fossero importanti per l’uomo greco: Zeus dopo essersi “pappato” Metis, incinta di Athena, la partorisce dalla testa. Dioniso nasce dalla coscia di Zeus in cui lo stesso Zeus lo aveva cucito strappandolo al grembo di Selene, senza menzionare Platone e l’uso che egli fa della metafora della riproduzione spostandola nell’ambito della creazione del filosofo. Il parto maschile, insomma, è un fantasma squisitamente greco. Questo ci dice Nicole Loreaux nello splendido studio già citato in cui ci parla di “invidia di gravidanza” e soffermandosi sulla mitica figura di quel Supermaschio di Eracle – le cui contaminazioni con il femminile non sfuggono al suo sguardo – ci racconta come la marginalizzazione delle donne nella polis greca, non abbia impedito che il femminile fosse per l’uomo greco “l’oggetto massimamente agognato” o che “il potenziamento della virilità del maschio greco ”avvenisse “attraverso l’appropriazione in tutto o in parte del femminile”. Appropriazione del femminile? Consisterebbe dunque in questo il furto cui si allude nel titolo Il femminile rubato? Sarebbe dunque il femminile, l’oggetto agognato da “rubare” alle donne?
Forse proprio di questo si tratta ne Il furto antico, una splendida tela dell’artista milanese Maria Micozzi che voglio qui ricordare per aver partecipato a molte delle nostre iniziative e per aver trasformato in arte l’orrore della violenza e da cui ho forse inconsapevolmente tratto ispirazione per la prima parte del titolo. Ma Chi ruba Che cosa e a Chi? La risposta non va da sé come forse ci aspetteremmo, perché è evidente che per rubare qualcosa a qualcuno, bisogna pure che questo qualcuno ne sia, per così dire, in possesso. E, a buon senso, tutto, tradizione inclusa, ci indurrebbe a pensare che a possedere il misterioso segreto dell’Eterno Femminino sia la donna. Ebbene, è qui, proprio qui che qualcosa d’imprevisto ci attende e ci sorprende, mettendoci di fronte a un nodo inaggirabile, un nodo teorico presente nel pensiero freudiano che dissolve e manda all’aria i palinsesti del buon senso. Di che si tratta è presto detto. In un importante scritto, Analisi terminabile e interminabile del 1937, dedicato all’esito conclusivo di un trattamento psicanalitico, Freud ci informa: il rifiuto della femminilità è, per entrambe i sessi, qualcosa di così potente e irriducibile e resistente al trattamento, da diventare “la roccia basilare” insuperabile su cui l’analisi si arresta. Come dire che né Lui né Lei ne vogliono saperne nulla, per ragioni diverse, del femminile. Sic stantibus rebus, corre allora l’obbligo di domandarsi se e in quale misura la conclusione cui giunge Freud, possa accordarsi con l’idea di una femminilità altamente desiderabile per l’uomo da rubare alla donna che di questa femminilità non ne vuole a sua volta sapere nulla – come l’isteria, d’altronde, da sempre insegna. Il femminile, il massimamente desiderato, è massimamente rifiutato. Eppure – malgrado Freud – che un’aspirazione al femminile e una tendenza alla sua valorizzazione sia stata e sia tuttora presente, almeno in linea teorica, in diversi contesti storici, lo abbiamo potuto constatare nella storia antica, lo abbiamo verificato nella rivalutazione del femminile e nel progetto di defallicizzazione avviato in Italia e in Francia.
Potrei portare un’infinità di altri esempi, anche recentissimi, in cui i riferimenti a questa specie di conversione al femminile si rincorrono moltiplicandosi. C’è persino chi si allarga sino a parlare di femminizzazione del mondo, di “regime edipico del non tutto” di “nuovo regno del non tutto”, c’è chi riscontra una “femminizzazione del sociale in atto” con toni alterni in cui l’oscillazione fra l’annuncio della buona novella e l’angoscia di una catastrofe del virile, resta indecidibile. E di tutto questo si dice e si scrive in un momento in cui la virilizzazione delle donne, la deriva del materno e persino la clinica – con il considerevole numero di quadri ossessivi femminili in aumento, assai più frequenti, un tempo, nei maschi – sembrano procedere, invece, in direzione di una preoccupante scomparsa del femminile. Come accordare queste differenti letture del sociale, questi appelli accorati al femminile – che ci giungono peraltro soprattutto da parte maschile – con il rigetto di cui ci parla Freud? Molto tempo è passato, certo, da allora e, oltretutto, Freud, nel registrare questo rigetto, si riferiva a persone nevrotiche che aveva in cura – si potrebbe obiettare. Ma – domando – le cose sono realmente diverse, oggi, per le persone che siamo soliti reputare “sane”? In quale luogo sconosciuto e lontano si nascondono questi uomini disposti a rinunciare alla virilità come unico metro di misura del loro e dell’altrui valore? E non è forse nel pericolo di questa inimmaginabile, insopportabile rinuncia alla dominanza che vanno cercate le radici della violenza? C’è però anche chi, come Rosy Braidotti, è più prudente e, non a torto, reputa questi appelli alla femminilizzazione come nuove versioni del vecchio “cannibalismo metafisico” e, inclemente, scrive:
Non posso fare a meno di chiedermi che cosa li abbia spinti a imbarcarsi in questo progetto di defallicizzazione. Che cosa esorcizzano questi filosofi nell’atto del loro divenire “femminilizzati”? Che cosa vogliono questi nuovi isterici? In questa manovra non vedo altro che il vecchio cannibalismo metafisico: esso esprime il desiderio maschile di continuare la tradizione egemonica che hanno ereditato; rivela l’attaccamento degli uomini al loro tradizionale luogo di enunciazione nonostante tutto. Invidia.
Ma torniamo a Freud: le ragioni teoriche del rigetto del femminile sono presto dette: “Protesta virile” per Lui, “invidia del pene” per Lei. Nessuna differenza, dunque, né Lei né Lui vogliono saperne nulla della femminilità e questo rigetto condiviso, è considerato da Freud “un elemento del grande enigma del sesso”. Enigma di facile soluzione. Non c’è nulla di misterioso, nulla di cui stupirsi se all’interno di un ordine simbolico fondato a misura d’uomo, in cui a rappresentare uomo e donna in modo neutro e indifferenziato, c’è un unico simbolo – il fallo – uomini e donne rifiutino, per ragioni diverse, la femminilità. E poiché questo rifiuto del femminile è indotto dallo stesso sistema che lo produce, come stupirsi se all’interno di una cultura fondata sul mito della potenza Lui difenda a colpi di macete, se necessario, la sua virilità traballante e Lei, per trovare Luogo in un simbolico monogenere che da sempre la esclude, è costretta a sgomitare e a virilizzarsi, al prezzo della sua alienazione?
Non è forse a questa semplificazione estrema di una “dualità indefettibile” che sono dovuti, oltre che la metafisica, i mali e i disagi delle nostre nevrosi?
E’ quanto basta per comprendere che il furto del femminile – con gli effetti di perdita di femminilità che comporta a depauperamento della donna e, nondimeno, dell’uomo – è opera, in definitiva, di un sistema che nel creare le condizioni per l’estinzione del femminile, ha finito per danneggiare se stesso promuovendo l’involuzione di una società uni-sessuata sempre più povera di donne. La trasformazione delle donne nella duplice versione di infelici maschere in carriera o in corpi scarnificati o debordanti per dire No a un femminile mercificato, è il culmine e il declino di quel sistema totalizzante che è il patriarcato. Dove trovare la donna fra questi due estremi? E il materno, desiderato e/o bandito, diventa traversia, dolore, nostalgia. Non può esserci scissione fra donna e madre, fra vergine e prostituta. Se la madre uccide la donna, la donna ripudia il materno che minaccia di annullarla come donna e la maternità, lungi dall’essere esperienza irrepetibile, assume i contorni sinistri di una condanna che spacca in due la persona.
Mi avvio a concludere con qualche riflessione aggiuntiva alle considerazioni già parzialmente anticipate sulla parte finale del titolo Inventare la donna. Seguirò la via più semplice andando a ritroso a quel passaggio di Lacan, tratto da Encore che, come ricordavo, suscitò a suo tempo grande scandalo fra le donne per via – si dice – di un’errata interpretazione.
Non c’è La donna, articolo definito per designare l’universale. Non c’è La donna perché… elle n’est pas toute.
Ho cercato di indicare, in diversi momenti del percorso, alcune linee guida per facilitare la comprensione di questo enunciato individuando nell’ordine simbolico il primato di un unico significante universale – il fallo – incaricato di rappresentare uomo e donna, sottolineando al tempo stesso la mancanza, l’assenza, di un simbolo equivalente atto a rappresentare la donna. Se si può dire che L’(o)uomo c’è, ed esiste – e come se esiste…- e che La donna non esiste, ciò è dovuto al fatto che il significante la è un significante che è “il solo a non poter significare nulla” in quanto esiste un unico simbolo – l’articolo maschile lo, sottinteso nel contesto – che vale per entrambe i sessi. L’antecedente teorico di questa unicità è nota e datata: lo troviamo in Freud là dove egli postula l’esistenza di una libido unica maschile per uomo e donna. Per una maggior comprensione dell’enunciato, occorre tuttavia tener conto di un altro aspetto importante: questo simbolo unico per rappresentare i due sessi, oltre che essere uno, è anche onnicomprensivo e, come tale, è anche un Uno-Tutto. Mi spiego: quando noi diciamo L’(o)uomo, in questo articolo maschile lo, noi intendiamo l’umanità tutta nel suo insieme, nella sua totalità e universalità e in questo insieme, in questo uni-verso, è incluso anche ogni di-verso, è inclusa dunque anche la donna come diversa, come Altro dall’Uno. Quando invece diciamo la donna, non intendiamo l’umanità nel suo insieme, uomo incluso, perché l’articolo femminile la, a differenza del maschile lo, non designa l’universale.
Questo ci permette di osservare che:
a) il primato-privilegio di genere è già pienamente dominante e operante nella nostra lingua, nella nostra grammatica e ciò non va senza conseguenze sullo sviluppo evolutivo e sulla formazione mentale degli individui che decide e incide, a sua volta, sul loro comportamento individuale e sociale;
b) l’assorbimento del femminile nel maschile, l’inclusione della donna nell’Uno-Tutto, comporta, inevitabilmente, quanto alla sua rappresentabilità, una forma di esclusione-cancellazione del femminile dall’ordinamento simbolico in cui viviamo Il furto del femminile e le traversie del materno. Inventare la Donna.
Lo constatiamo ogni giorno: in politica, nei luoghi istituzionali e di lavoro in cui l’egemonia di un solo sesso all’interno del simbolico è addirittura soverchiante. L’affermazione di Lacan, così formulata, contiene tuttavia un’ambiguità teorica che va evidenziata: non è che la donna non c’è, non esiste perché è non-tutta, (l’essere non tutta non è la causa, la ragione della sua non esistenza) ma è vero il contrario: Lei è non-tutta non perché manchi di qualcosa, ma perché manca nel simbolico un significante che la rappresenti come donna il che comporta che Lei, rispetto all’universo maschile dell’’Uno-Tutto – di cui pure fa parte – sia irrimediabilmente fuori come Altra. L’individuazione e l’attribuzione della mancanza all’ordine simbolico piuttosto che alla donna, non attenua tuttavia minimamente gli effetti deleteri che tale mancanza produce su di Lei quanto alla suo status, individuale e sociale, di donna. Va dunque ridimensionata una fastidiosa tendenza, presente nel lacanismo a insistere, con un’enfasi fuorviante davvero eccessiva, sulla positività e sui vantaggi che deriverebbero alla donna da questa sua posizione di non tutta e a denegare il suo innegabile risvolto negativo che viene oscurato tramite la sostituzione del concetto di mancanza con quello di Alterità, per cui si può dire che “il non tutto” che la riguarda non ha nulla a che fare con la mancanza ma “sarebbe l’Altro diverso dall’Uno-Tutto” lasciando così completamente in ombra l’ideologia che sta alla base della mancanza simbolica. A rinforzare con enfasi, se possibile, ancora maggiore, questa captatio benevolentiae a favore della donna – su cui nutro, invero, più di qualche sospetto – è l’intima connessione fra questo suo essere non tutta, pas toute, e il suo più di godimento – “supplementare” al di là del fallo – che le viene attribuito e rispetto al quale il godimento maschile, viene relegato al rango più modesto del “godimento dell’idiota”. Inutile dire, per inciso, che l’idiota evocato da Lacan per definire il godimento fallico, non è imparentato, neppure alla lontana con l’idea che ne aveva Dostojewsky incarnata nella stupefacente figura del Principe Miskin nel suo capolavoro omonimo. Chiuso l’inciso.
Ebbene, al termine di questo lungo giro che mi auguro abbia stimolato pensieri e interrogativi, una cosa è certa: ciò di cui La donna è portatrice è un’irriducibile complessità e Alterità – di qui l’audacia di Lacan di interpretare “una faccia dell’Altro, la faccia Dio, come quella che è sostenuta dal godimento femminile”. Su questa prossimità della donna al divino – non al Dio Cristiano ma a Dioniso, dio gnostico – sulla sua dimensione profetica che anima le streghe di tutti i tempi, che sono poi semplicemente le donne per quel tanto che si lasciano permeare dal loro femminile che è sempre in comunione con Dio o con il daimon che, come la donna, “cammina sulla traccia di Dio” “testimone del demone e quindi della felicità” (eudaimonia) – c’è ancora tutto da dire. E a una complicità non della donna con Dio ma di Dio con la donna, dedica attenzione Baudrillard facendo riferimento alla storia di Lilith e Shekinah che ci è raccontata dalla Qabbalah. Dio, dopo aver creato la prima donna, Lilith, pari ad Adamo e ribelle, rivale dell’uomo, crea Eva – uscita da una costola di Adamo come un suo derivato – per dargli una compagna. Ma Dio, a sua volta, per non rimanere solo, si sceglie come compagna Shekinah che rappresenta la presenza di Lui nel mondo ma che, a un certo punto, adirata con Dio per via del suo comportamento nei riguardi degli Ebrei durante la distruzione del Tempio di Gerusalemme, decide di piantarlo in asso e di andarsene da sola per il mondo a fare il Bene. Dio allora, si cerca un’amante e sceglie Lilith la ribelle, il principio del Male, ribelle a Dio e infedele, tradendo così, per primo, quei valori assoluti del mondo – Unità Completezza, Integrità – che avrebbe potuto benissimo coltivare restando fedele a Shekinah, da lui scelta come compagna a garanzia del Bene nel mondo e rifiutando Lilith.
Dio sceglie dunque il Male? Perché Dio sceglie Lilith, la ribelle, il principio del Male invece che colei che avrebbe certamente garantito il Bene? Perché il Male è intelligente e Dio, che è onnipotente, sa bene che “la potenza stessa si vieta, si destituisce, si disinveste, alla fine lavora segretamente contro se stessa”. Lui sa che tutto ciò che aspira alla Totalità dell’Uno-Tutto, al Bene assoluto e “infrange la dualità”, porta alla disintegrazione per “risorgenza violenta della dualità” e sa anche che un atto etico – lo ricorda Zizek che ricorda Lacan – comporta non una mossa “al di là del Bene e del Male” ma una mossa “al di là del Bene”. La donna, il femminile – assieme alla schiera dei di-versi di cui l’universo è popolato, – testimoniano di questa “risorgenza violenta” di una “dualità” insopprimibile sempre liquidata, di una dualità infranta che sempre ritorna e si ripresenta, di una dualità che “viene a restituire un’assenza, un vuoto…sommersi da una presenza totale” e che frantuma, con questo ritorno, la “Realtà Integrale”.
E’ questa, proprio questa, l’origine genealogica della paura dell’uomo nei riguardi della donna: paura di questo ritorno, di questo ri-presentarsi della dualità. Ma Dio non ha paura perché sa che nello scegliere Lilith, nello scegliere il principio del male e nel rifiutare il Bene garantito da Schekinah, in realtà sceglie il bene, “al di là del Bene”. La donna è questa assenza, questo vuoto “sommerso da una presenza totale” dell’uomo, per questo non c’è, per via di un crimine, e occorre inventarla…
Ma, ad inventarsi, e a poterlo fare, non c’è che Lei.
Come? Riabitando il femminile rubato, testimoniando, attraverso un atto etico e politico radicale, che cosa vuol dire essere una donna mostrando la vergogna e smontando la menzogna di coloro che conservando intatta la logica dell’Uni-verso contro il di-verso, propagandano il valore del femminile senza combattere, con gli atti, la cultura che ha permesso di eliminare dalla storia la metà del genere umano.
Paola Zaretti
Convegno Care Cassandre 23 Novembre 2008