di Paola Zaretti /Maria d’oro Maria di catrame invito presso Università Ca’ Foscari di Venezia a cura di Bruna Bianchi
Maria d’oro, Maria di catrame. Radicamento e sradicamento nel pensiero e nella vita di Simone Weil
Niente di meglio, forse, per farsi un’dea dello sradicamento, che ascoltare le parole di Medea rivolte agli Argonauti :
Parlami, terra, fammi sentire la tua voce! Non ricordo più la tua voce! Parlami sole! Dov’è il punto dove posso ascoltare la vostra voce? Parlami terra, parlami, sole.
Forse vi state perdendo per non tornare più? Non sento più quello che dite! Tu, erba, parlami! Tu, pietra, parlami! Dov’è il tuo senso, terra? Dove ti ritrovo?
Dov’è il legame che ti legava al sole?
Tocco la terra coi piedi e non la riconosco! Guardo il sole cogli occhi e non lo riconosco.
(Euripide, Medea)
Maria d’oro Maria di catrame è una storia che M.me Weil raccontava a Simone: l’eroina, mandata nel bosco dalla matrigna, arriva a una casa in cui le viene chiesto se vuole entrare dalla porta d’oro o da quella di catrame e lei risponde: “Per me il catrame va benissimo”. Era la risposta giusta e le cade addosso una pioggia d’oro. La stessa cosa non succede alla figlia della matrigna che sceglie la porta d’oro e si ritrova addosso il catrame. Dobbiamo credere a Simone Petrémont, l’ amica di Weil, autrice della migliore biografia in circolazione, quando riferisce che questa favola influenzò tutta la vita Simone. (1)
Ma forse a Dio piace utilizzare i rifiuti, i pezzi difettosi, gli oggetti di scarto. (2)
Si direbbe che ci sono anime irrimediabilmente scartate dal servizio di dio per insufficienza della natura. Io tra queste. Vi si può rimediare? C’è un procedimento per far crescere il grano sulla pietra? (3)
Vedere un paesaggio com’è quando io non ci sono (…). Quando sono in qualche luogo, io insozzo il silenzio del cielo e della terra col mio respiro e col battito del mio cuore. (4)
Ho scelto di proporvi, per cominciare, una citazione in cui la descrizione della figura di Simone Weil, questa grandissima donna, è esente da odor di santità, spinta, nel farlo, da un certa insofferenza verso ogni forma di idealizzazione idolatrica nei riguardi di chiunque, inclusa questa nostra eroina del pensiero – è il caso di dirlo – che ha combattuto l’idolatria per tutta la vita e per la quale – a ricordarcelo è Domenico Canciani – “pensare è un atto eroico”. (5)
Non si tratta soltanto di una personale idiosincrasia, in generale, alla divinizzazione di personaggi eccellenti ma anche del fatto che la maggior parte delle interpretazioni del suo pensiero – religiosa, politica, metafisica, ermeneutica – moltiplicatisi soprattutto a partire dagli anni ’80, trascurano/oscurano, a mio avviso, degli aspetti importanti della sua vita testimoniati dalla sua biografia. Di qui la scelta di iniziare dalla descrizione, solo appena disincantata, di Gustav Thibon – nella cui fattoria fu ospitata negli ultimi anni della sua vita – il quale non senza benevolenza, la riteneva tuttavia incapace di “distaccarsi dal proprio distacco”, di giungere a quell’annichilimento di sé, a quella “morte dell’anima” tanto agognata, incapace, insomma, di districarsi da quell’io ingombrante di cui, come ogni mistico/a che si rispetti, celebrava la necessaria distruzione:
Lei che per un suo piacere o bisogno non avrebbe accettato che il suo prossimo facesse il più piccolo sacrificio, sembrava poi non tener conto delle complicazioni, persino della sofferenza che imponeva alla vita degli altri quando si trattava di realizzare la sua vocazione all’annientamento…Voleva dimenticare se stessa e si ritrovava proprio in questo dimenticarsi; amava il prossimo con tutto il suo essere, ma la sua dedizione, troppo spesso, passava a lato dei veri desideri e dei veri bisogni degli altri….Questa creatura, che voleva piegarsi a tutti i moti della volontà divina non sopportava che il corso degli eventi o la benevolenza degli amici intervenissero a spostare di un solo pollice le tappe stabilite dalla sua volontà di immolazione…Il modo con cui faceva la guardia attorno al suo vuoto, rivelava ancora una terribile preoccupazione di sé…Il suo io era una parola che lei forse era riuscita a cancellare, ma che rimaneva sottolineata. (6)
“Realizzare la sua vocazione all’annientamento”, “fare la guardia attorno al suo vuoto”, attuare quel “distacco” che Simone considerava, assieme al suicidio, uno dei due modi di darsi la morte – “Due modi di uccidersi: Suicidio o distacco” – scrive ne L’ombra e la grazia, (7) – non sarebbero dunque bastati a Simone, suo malgrado, a cancellare una parola come io la cui distruzione, indispensabile per far posto a Dio, rappresenta uno dei programmi del suo percorso mistico:
Il peccato in me dice io. (8)
Non c’è assolutamente nessun altro atto libero che ci sia permesso, eccetto la distruzione dell’io. (9)
Un’entità – questo io – la cui presenza imbarazzante contrasta decisamente con il suo desiderio di cancellarsi, di non esistere per gli altri:
Perché per gli altri in qualche modo io non esisto, sono color foglia morta, come certi insetti.(10)
entrando in conflitto con la sua vocazione a de-crearsi. Decreation: ecco – assieme ad “attenzione”, “azione non agente”, “sventura”, “amore senza oggetto”, e ad altre ancora – la parola-chiave che riassume e illumina l’intero percorso di Weil e che va considerata all’interno della sua concezione della creazione (oscillante fra una concezione gnostica – la creazione come caduta – e la concezione biblica di una creazione buona). Un termine, decreation, su cui sarà necessario tornare per indagare il nesso che lo lega allo sradicamento e alla sventura. Basti, per ora, questa anticipazione:
Solo la sventura estrema produce pienamente la sofferenza redentrice. E’ dunque necessario che essa si dia perché la creatura possa decrearsi. (11)
Il male, dunque, inteso come distanza fra la creatura e il Creatore, è una “condizione della de-creazione” e la de-creazione un modo per sopprimerlo. Ciò premesso, entro nel vivo, ricordando innanzi tutto che Weil è una pensatrice estrema, radicale, e che la sua passione per la radice, la sua esigenza di radicamento, è il rovescio speculare di un’ esperienza di sradicamento. Concentrerò la mia attenzione, in particolare, su due enunciati che incontriamo ne L’Enracinement e che nel corso di questo lavoro proverò ad approfondire allontanandomi parzialmente da questo testo – che non è, da un punto di vista formale, il migliore e che qualcuno ha persino definito, a torto o a ragione, un libro nato morto – per attraversare altri scritti in cui a predominare è un linguaggio frammentato e rapsodico più confacente al contenuto e al ritmo del suo pensiero, del suo respiro, e in cui l’esperienza dello sradicamento perde la connotazione esclusivamente negativa che ha in questo testo per assumere un diverso significato.
Chi è sradicato sradica. Chi è radicato non sradica. (12)
Ecco, è attorno a queste due affermazioni lapidarie, in perfetto stile weiliano e in apparenza semplici, contenute ne L’ Enracinement – questa sorta di testamento politico-sociale, malamente tradotto nella nostra lingua con La prima radice, inattuale sia nel ’43 che nel ’49, anno della sua pubblicazione, ma le cui lucidissime previsioni ben descrivono il progresso degli ultimi 50 anni – che proverò ad approfondire il nesso esistente fra questi due concetti: radicamento e sradicamento, un legame, come vedremo, ricco e complesso che nei due enunciati di Weil rimane velato o, per meglio dire, implicito così come lo era la sua fede. (13). Si tratta di due affermazioni forti, conformi allo stile di pensiero e di scrittura di Weil, enunciate nella forma apparente di una opposizione. Due concentrati di pensiero “duri” e puri” “come diamanti”, li potremmo definire facendo loro aderire quel che Cristina Campo dice, in generale, dei suoi libri. Due enunciati che meritano attenzione non solo per la possibilità che ci offrono di indagarne pieghe e risvolti e cavità non immediatamente visibili, ma anche perché ci permettono di dilatarne la sfera di esperienza e di pertinenza ben oltre i confini del politico nel cui ambito Simone li colloca e li analizza in questo testo. Si tratta, dunque, di sconfinare dall’orizzonte prevalentemente sociale e politico nel cui ambito Weil descrive le manifestazioni di quella pericolosissima malattia che è la “malattia dello sradicamento” – ambiti da lei elencati e puntualmente analizzati nei loro molteplici aspetti: la guerra e la disoccupazione, gli effetti delle conquiste e della sottomissione delle popolazioni conquistate e la geografia, la prostituzione e la condizione contadina e operaia, la cultura – per guardare alla condizione umana di sradicamento non solo in un’ottica sociale e politica (14), ma anche sotto il profilo di quello sradicamento dalla vita che è la morte, dando uno sguardo, insomma, alla vita e alla morte di Weil alla ricerca di una possibile connessione.
Come ci ricorda S. Petrémont – l’amica di Simone incontrata sui banchi di scuola – fu durante l’anno in fabbrica che ebbe inizio per Weil un periodo infelice in cui “incominciò a sentire impresso su di sé il marchio della sventura”. (15). E poiché la sventura non è altro che uno sradicamento dalla vita, è dello sradicamento di Simone – di cui il suo radicalismo rappresenta il rovescio – che sono tentata soprattutto di occuparmi. Seguirò, per raggiungere lo scopo, un certo itinerario confidando nella sua utilità. Per avere un’idea precisa di che cosa Simone intenda per sventura leggiamo, innanzi tutto, un brano tratto da una raccolta di scritti datati fra il ’41 e il ’43 che da sempre m’incanta:
Quando con il martello si batte un chiodo, il colpo ricevuto dalla larga testa del chiodo si trasmette alla parte appuntita per intero, senza alcuna perdita, sebbene questa parte non sia che un punto. L’estrema sventura, che è insieme dolore fisico, smarrimento dell’anima e degradazione sociale, costituisce questo chiodo. La punta è applicata sul centro stesso dell’anima. La testa del chiodo è l’intera necessità diffusa attraverso la totalità dello spazio e del tempo. La sventura è una meraviglia della tecnica divina. E’ un dispositivo semplice e ingegnoso che riesce a infliggere nell’anima di una creatura quell’immensa forza cieca, bruta e fredda. La distanza infinita che separa dio dalla creatura converge tutt’intera in un unico punto per trafiggere un’anima al suo centro. L’uomo al quale accada una cosa simile non ha parte alcuna nell’operazione. Si dibatte come una farfalla che venga appuntata viva in un album. Ma attraverso l’orrore può persistere nella volontà di amare. (16)
Delle molte e diverse condizioni di sradicamento inteso negativamente come malattia, elencate e descritte ne l’Enracinement, ne ricordo, per brevità, solo una, riguardante la cultura, poeticamente descritta da Weil attraverso l’immagine di un contadinello infelice, alunno delle elementari, che pur ripetendo “docilmente che la terra gira intorno al sole” e dimostrando con ciò di saperne più di Pitagora, “non guarda più le stelle” perché “il sole del quale gli si parla a scuola non ha nessun rapporto con quello che vede”. (17)
La cultura – rincara impietosa – è uno strumento maneggiato da professori per fabbricare professori che a loro volta fabbricheranno professori. Fra tutte le forme attuali assunte dalla malattia dello sradicamento, quello dello sradicamento della cultura è una delle più allarmanti. La prima conseguenza di questa malattia è generalmente, in tutti i campi, che essendo state stroncate le relazioni ogni cosa viene considerata come fine a se stessa. Lo sradicamento genera l’idolatria”. (18)
Al centro del mio interesse e di questa ricerca, è però, come dicevo, il peso che l’esperienza dello sradicamento – un particolare genere di sradicamento, come vedremo – ha assunto in quella vita e in quella morte singolari che sono la vita e la morte di Weil. Una morte per fame, per fame di Dio. Ascoltiamo queste parole in cui il tema della fame e del nutrimento, assieme al “distacco”, insistono sino a diventare quasi un’ossessione:
La beatitudine eterna è uno stato in cui guardare è mangiare. (19)
La parte eterna dell’anima si nutre di fame. (20)
Amare nel prossimo la fame che lo morde e non il nutrimento che in lui ci è offerto per calmare la nostra fame, questo indica un distacco totale. Implica la rinuncia a mangiare qualcosa dell’uomo, implica che non si vuole più mangiare altro che Dio. (21)
Accettare il vuoto. Si ritrova sotto molte forme (…). Sete, fame, castità – privazioni carnali di ogni tipo – nella ricerca di Dio. Forme sensibili del vuoto. Il corpo non ha altro modo di accettare il vuoto. (Aver fame, sete di Dio). (22)
C’è una colpa sola: non aver la capacità di nutrirsi di luce. (23)
Se l’anima gridasse verso Dio la sua fame del pane di vita, senza interruzione alcuna, instancabilmente, come grida un neonato che la madre dimentica di allattare…Le grida che io lanciavo quando avevo una o due settimane risuonino in me senza interruzione per quel latte che è il seme del padre. (24)
Quando non si mangia l’organismo digerisce la propria carne e la trasforma in energia. (25)
Enunciato terribile, evocante un processo di auto-divoramento
Ma quando si è totalmente privi di energia terrestre si muore. Finché il mio cuore, i miei polmoni, le mie membra non sono completamente paralizzati, è la prova sperimentale che sulla pietra c’è una goccia d’acqua per il grano celeste. Giungere a dargli da bere anche se questo fa morire di sfinimento la carne. Importa solo che la carne e il sangue si dissecchino prima dello stelo divino, nient’altro che questo.
Ma c’è un momento in cui la fame, urlata, di “pane di vita” e il divino nutrimento agognato e finalmente ricevuto, fanno virare l’incredulità in certezza:
Dobbiamo solo attendere e chiamare. Non chiamare qualcuno dato che non sappiamo ancora se c’è qualcuno. Dobbiamo gridare che abbiamo fame e che vogliamo del pane. Grideremo più o meno a lungo, ma finalmente saremo nutriti e allora non soltanto crederemo ma sapremo che esiste veramente del pane. Quando ne abbiamo mangiato, quale prova più sicura potremmo desiderare. Fintanto che non ne abbiamo mangiato non è necessario e neppure utile credere nel pane: L’essenziale è sapere che si ha fame. Non è una credenza questa, è una conoscenza assolutamente certa che non può essere oscurata che dalla menzogna. Tutti coloro che credono che vi è o vi sarà un nutrimento quaggiù mentono. (26)
Si arriva alla fede, dunque, attraverso l’incredulità e non attraverso “le credenze che colmano i vuoti, che addolciscono le amarezze”(27), non attraverso le pratiche consolatorie. In questo senso “l’ateismo è una purificazione”. (28). Simone Weil non è una convertita – lo rileva Blanchot ne L’infinito intrattenimento – (29) ma a dircelo è lei stessa: “Nel mio caso parlare di conversione non ha senso”. (30). Sul rifiuto di un nutrimento che non sia il “nutrimento celeste” scrive ancora:
Tutti gli oggetti dei nostri attaccamenti costituiscono, insieme al nutrimento vero e proprio, il pane di quaggiù (…). Non dobbiamo chiedere il pane di quaggiù. (31)
Non c’è nutrimento quaggiù e Trolless – così l’aveva soprannominata il fratello Andrè – che alle discese preferiva le salite, che “mangiava come un passerotto”, che faceva dire a sua madre: “…quel che mi tormenta è che questa figlia s’ammazza” (32), che faceva sì che i suoi genitori fossero torturati dalle sue “follie eroiche”, che provava disgusto quando un frutto non era perfetto, che indagava “sulla possibilità, per gli esseri umani, di vivere senza mangiare (…) nutrendosi solo di luce solare e di certi corpi minerali” (33), che pensava, come Platone, che il corpo fosse un tomba (34), che scherzava su un suo deperimento precoce dovuto al latte materno alterato da una malattia, lamentandosi di essere stata avvelenata nella sua primissima infanzia – preferiva quello di lassù. L’elenco potrebbe continuare…Si tende a tacere, a rimuovere questo aspetto della vita di Simone, questa vocazione suicida imputando ad altri fattori – che sicuramente vi hanno concorso – la sua tragica fine anzitempo. Su questa morte, un suicidio differito, qual è la morte per fame, mi pare di avvertire, in molti studiosi e interpreti del suo pensiero che negli ultimi trent’anni hanno contribuito a un’amplissima produzione bibliografica sulla figura e sull’opera di Weil, un atteggiamento più prossimo a una censura, a una rimozione, che a un comprensibile pudore, qualcosa su cui sor-volare scivolando, oscurando, ridimensionando, santificando.
Non c’è in Simone – scrive Canciani facendo riferimento alle riflessioni contenute nei Quaderni – alcuna volontà suicida o morbosamente sacrificale. C’è, questo sì, la volontà espressa di accettare che la condivisione della sventura comporti anche la propria morte. In questo senso e solo in questo senso, la morte le appare il solo modo per realizzare la sua personale vocazione. (35)
Se è vero che alcune affermazioni contenute nei Quaderni sembrano andare in direzione contraria al suicidio inteso come morte reale o immaginaria e a favore di quella morte simbolica realizzabile attraverso il “distacco”, sappiamo bene che fra ciò che si vuole, si pensa, si dice, si scrive e i nostri atti non sempre c’è conformità e non perché quel che si vuole, si dice o si scrive sia falso ma perché esiste un sapere, un sapere su di sé che il soggetto ignora, un sapere insaputo che è il sapere inconscio. Aver scritto “la vita è breve e vorrei viverla per sempre”, non ha impedito a Yukio Mishima di suicidarsi né, a chi dice “ti amo”, giusto per stare alla cronaca dei nostri tempi, di fare dell’amore una tomba.
Bisogna che tu viva almeno un lungo spazio di tempo in modo puntuale, per provare a te stessa che ne sei capace. Altrimenti, vuol dire che non sei in grado di essere al mondo – che devi morire. (36)
Quale dono più grande della morte poteva essere fatto alle creature. (37)
Possa io sparire perché le cose che vedo, non essendo più le cose che io vedo, divengano perfettamente belle. (38)
Il corpo è una tomba. La parte spirituale dell’anima deve servirsene per racchiudere, murare la parte carnale…per uccidere la parte carnale. Possa il mio corpo essere uno strumento di supplizio e di morte per tutto ciò che è mediocre nella mia anima. (39)
Sono parole di Simone. Si può ben teorizzare sul fatto che la morte qui invocata non avrebbe nulla a che fare con quella morte reale che è il suicidio ma quand’anche così fosse, capita che la morte simbolica attraverso il “distacco” non sempre riesca felicemente nel suo difficile passaggio di registro: da quel registro del reale o dell’immaginario – apertamente condannati da Simone – al simbolico. Di questa condanna ecco la formulazione:
Atti effettivamente compiuti e tuttavia immaginari. Un uomo tenta il suicidio e viene salvato; e, dopo, non è maggiormente distaccato di quanto fosse prima. Il suo suicidio era immaginario. Il suicidio, certo, lo è sempre, per questo è proibito. (86)
Resta la sua, nondimeno, una fine – quale che ne sia la “lettura” – a proposito della quale mi piace ricordare un passo de La Gaia Scienza in cui Nietzsche definisce così i grandi maestri:
I maestri di prim’ordine si fanno riconoscere dal fatto che così nel grande come nel piccolo sanno trovare in un modo perfetto la fine, sia questa la fine di una melodia o di un pensiero, sia quella dei cinque atti di una tragedia o di un affare di stato (…(40)
Sia questa… aggiungerei, la fine di una vita:
Ci sono soltanto due istanti di nudità e di purezza perfetta nella vita umana: la nascita e la morte. Non è possibile amare Iddio in forma umana senza offendere la divinità, se non come neonato e agonizzante. (41)
La morte è la cosa più preziosa che sia stata data all’uomo. Perché l’empietà suprema è usarla male. Morir male, uccidere male. (Ma come sfuggire, insieme al suicidio e al delitto?). (42)
Inutile dire che indagare sul rapporto di Weil con la vita e con la morte – con quella “follia d’amore” che le fa dire: “Dio esiste perché io lo desidero” – attraverso la sua opera, ci conduce sul terreno delicato del rapporto fra autore/autrice ed opera, e, per non farci mancare proprio nulla, potremmo ricordare, a questo proposito, un’altra sentenza nietzschiana secondo cui quando si scrive “bisogna scrivere con il proprio sangue”. Lo possiamo fare, nel caso di questa grande donna, senza forzature per via dell’ andamento doloroso e cruento della sua scrittura – “Si scrive come si partorisce” – dice Simone – (43) e nonostante la sua dichiarata repulsione “invincibile quasi fisica” per il filosofo, con il quale, al di là delle differenze, esistono, per sua stessa ammissione e – come Marco Vannini sembra suggerire quando vede nell’ Übermensch nietzschiano “una cifra dell’uomo della grazia”(44) – non poche affinità. In merito al rapporto autore/autrice-opera, possiamo sin d’ora affermare che, nel caso di Weil, “l’unità inscindibile dell’essere, del vivere, dell’operare” è qualcosa di visibilmente presente nella ricca biografia dedicatale, dopo la morte e su richiesta della madre, dall’ amica Simone Petrémont. E tuttavia il rispetto dovuto a questa straordinaria figura di donna ci impone di non trascurare i timori da lei espressi, di suo pugno, su questo delicato argomento:
Raccontare la vita di grandi uomini, separandola dalla loro opera, ha come risultato inevitabile di far risaltare soprattutto le loro debolezze, perché è nella loro opera che hanno messo il meglio di se stessi. La cosa più odiosa, però, è che in generale tutte le meschinità, tutte le bassezze sono raccontate in modo che appaiano come il prezzo del genio….si dovrebbe concepire un metodo per lo studio della vita dei grandi uomini, che consistesse nel cercarvi i segni di quella grandezza che si manifesta pienamente solo nelle opere; le piccinerie non verrebbero dissimulate, però apparirebbero come il limite e non il fattore essenziale del genio. I biografi moderni fanno, in generale, tutto il contrario: non raccontano la vita di un grand’uomo, ma quella di un uomo piccolo che, non si sa per quale miracolo, ha fatto grandi cose. (45)
Spero, non essendo biografa, non sia davvero il mio caso. Ma è certamente il caso – secondo Simone – di Otto Rüle che nel suo libro Karl Marx cerca di spiegare Marx servendosi delle teorie di Freud cosicché “il tratto essenziale in Marx” che spiegherebbe “tutto il resto”, sarebbe “il cattivo funzionamento dell’apparato digerente” e il suo “bisogno di assomigliare a Dio”. (46). Ebbene, tenendo nel giusto conto la severa critica espressa da Weil, qui come altrove, nei riguardi della pedagogia, della psicologia e del freudismo – critica che sottoscrivo in pieno anche se, diversamente da lei, l’idea di considerare Platone un’ alternativa a Freud e di mettere sulla porta di Oikos la scritta che compariva sulla porta dell’Accademia: “Qui non entra chi non è geometra” non mi seduce affatto – mi sono chiesta se riguardo alla vita e all’opera di questo spirito inquieto, sia possibile affermare ciò che Margherite Yourcenar – che pure ci mette in guardia dalla “curiosità volgare e dal “gusto per l’aneddoto biografico”- scrive riguardo all’opera del grande scrittore giapponese Yukio Mishima ricordando quell’opera estrema rappresentata, a suo dire, dalla sua morte. Nel definire una di queste opere, Le confessioni di una maschera, “un resoconto quasi clinico”, Yourcenar affida la motivazione del suo libro dedicato a Mishima – Mishima e la visione del vuoto – a queste parole:
Quello che ci preme è vedere attraverso quali itinerari il Mishima brillante, adulato, o, il che è lo stesso, detestato per le sue provocazioni e i suoi successi, sia un uomo determinato a morire. In realtà, – aggiunge – una ricerca di questo tipo è in parte vana: l’inclinazione per la morte è frequente negli esseri dotati di grande avidità per la vita. Se ne trova traccia, in Mishima, fin dalle prime opere. (47)
Ecco, è su questa avidità per la vita e sul suo inscindibile legame con la morte che vorrei soffermarmi, persuasa come sono che della morte si possa dire, come della vita, a ciascuno/a la sua. Di questo amore per la vita si trova traccia, come vedremo, anche nell’ opera del giovane filosofo goriziano suicida Carlo Michelstaedter, nella sua tesi di laurea – La Persuasione e la Rettorica – mai presentata al Collegio dei professori, e in altri scritti. Credo che in un contesto come questo – in cui la passione di Weil per l’Assoluto occupa il posto centrale che le spetta, il riferimento a Mishima e a Michelstaedter – due figure letterariamente e filosoficamente importanti del ‘900 – non sia azzardato. Seguendo la traccia indicata da Yourcenar e nella piena consapevolezza della parziale vanità in cui una ricerca di questo genere inciampa – potrei dire, non diversamente dalla scrittrice, che quel che ci interroga, nel caso di Simone, è precisamente il rapporto fra la sua avidità per la vita e un amore persino più forte per la morte che viene da lei così enunciato ne L’ombra e la grazia:
Egualmente, bisogna amare molto la vita per amar ancora di più la morte. (48)
letteralmente, la purezza totale o la morte. Si direbbe che lo stato di perfezione è vietato a un’anima di questa natura se non nel preciso istante della morte. (49)
Se è dunque vero che Simone non era affatto insensibile alle gioie della vita e che mai avrebbe definito il suo modo di vivere una rinuncia (50) – di qui la sua dichiarata ammirazione per Rosa Luxemburg e per il suo amore verso la vita e verso il mondo – escludere in lei una tendenza al sacrificio è davvero difficile se si pensa alla sua durissima esperienza in fabbrica e al suo stile di vita ispirato all'”Amore povero nel Simposio – magro, piedi nudi, senza rifugio” che la portò a vivere, ad un certo punto, al freddo, in condizioni durissime, rifiutando ogni conforto troppo umano, fino a scegliere di dormire per terra. Simone, come Carlo, come Mishima, è una “testimone dell’Assoluto” – e Carlo Michelstadter che pure sui cercatori d’Assoluto – e dunque anche su stesso – non manca di fare dell’ironia, scrive :
L’assoluto non l’ho mai conosciuto, se non come chi soffre d’insonnia conosce il sonno, come chi guarda l’oscurità conosce la luce. (51)
Se non nel modo, dunque, della mancanza, della fame. Un’ altra sorprendente affinità fra questi due temerari del pensiero, Carlo e Simone, pur dissimili nel loro modo di attuare la loro vocazione, è l’ insistente ricorso all’antichissima metafora della fiamma e del fuoco, immagine del pneuma, di quell’energia soprannaturale che è lo Spirito:
Lo scambio d’amore tra Dio e la creatura è un dardo di fuoco verticale come la folgore. (52)
Tutto deve diventare fuoco, bisogna passare per il fuoco. Ma quanti sono diventati fiamma si trovano a casa loro nel fuoco. (53)
Persino il pensiero di un Eros incondizionato, senza oggetto non può sorgere – secondo Simone – se non in un’anima divorata completamente dal fuoco dello Spirito Santo, come lo erano di certo quelle dei pitagorici. (54)
Ecco cos’è l’amore soprannaturale per Simone. E Carlo, poeticamente:
Così battono le fiamme della vita innumerevoli, torbide, fumose o limpide e luminose, che il vento disperde e abbatte, o che guizzano dritte verso il terreno, e il crepitare largo riempie lo spazio d’una voce sola che ha in sé miriadi di voci. Così riluce e strepita mentre io lontano sto col mio cuore solitario e chiedo con l’angoscia di chi si vede distruggere il terreno dove posa – chiedo perché non anch’io mi possa abbandonare all’impeto selvaggio della vita, perché non anch’io faccia fiammeggiare la mia fiamma e risonare il mio nome. (55)
…in uno sarai tu stesso e la vita: e farai di te stesso fiamma. (56)
E a proposito dello Stabat MaterMa ad infiammare Carlo, contro tutto ciò che è falso e meschino, è anche, nondimeno, quel “vegliardo divino” di Tolstoj. Mi sono chiesta, per inciso, se Pasolini avesse in mente qualcosa del genere quando scriveva che “la morte compie un fulmineo montaggio della nostra vita”. Fu certamente questo l’ inferno luminoso di Carlo Michelstaedter di cui nell’ ottobre 2010 ricorreva il centenario della morte. Fu questo il “lampo che rompe la nebbia” di cui ci parla ne Il Dialogo della salute, un testo datato 1910 ispirato al modello letterario dialettico di stampo platonico non privo di influssi leopardiani. Un Dialogo in cui la via del suicidio è annunciata. “Il lampo che rompe la nebbia”: ecco, detto come meglio non si potrebbe, che cos’è l’atto suicida: un atto di vitalità paradossale attraverso il quale si tenta di vivere quella vita mai vissuta, mai conosciuta se non nella sua sventurata dimensione di invivibilità. Paradosso che abbiamo visto così enunciato dal grande scrittore giapponese Yukio Mishima:
La vita umana è breve, ma io vorrei vivere per sempre.
Parole affidate a un biglietto che precede la sua morte, con il seppuku, all’età di 45 anni, nel disperato tentativo di ricomporre la scissione fra arte e vita, fra anima e corpo.
E Carlo:
La troppa gioia toglie la ragione davvero, fa impazzire o morire – onde si dice: la lampada si spegne per mancanza d’olio, ma per troppo olio viene soffocata. (57)
II pensiero della morte sfiora Simone all’età di quattordici anni:
A quattordici anni sono caduta in una di quelle disperazioni senza fondo tipiche dell’adolescenza, e a causa delle mie mediocri facoltà naturali ho pensato seriamente alla morte. (58)
Su questo eccesso di vita e di pienezza, ascoltiamo Maria Zambrano:
La tragedia di queste creature è in definitiva la mancanza di spazio interiore. Se guardiamo da vicino, la prima cosa che avvertiamo è il loro eccesso di pienezza, un mondo compresso affollato di cose: personaggi in embrione, speranze e nostalgie, abbozzi e progetti, orme e presentimenti di realtà senza nome, un mondo che confina e sta nell’ineffabile ma non per questo è meno reale. Che mancano di spazio non significa semplicemente che mancano di spazio fisico ma che mancano di spazio adeguato in un mondo che gli ha inculcato credenze che non consentono loro di accoglierle. (59)
Pesanteur, peso, gravità. Ecco alcune parole piene di senso che rendono legittimo l’ accostamento fra queste due grandi figure. Ed ecco l’incipit, stupendo, della tesi di laurea mancata di Carlo Michelstaedter:
So che voglio e non ho cosa io voglia. Un peso pende ad un gancio e per pender soffre che non può scendere: non può uscire dal gancio poiché quant’è peso pende e quanto pende dipende. Lo vogliamo soddisfare: lo liberiamo dalla sua dipendenza; lo lasciamo andare, che sazi la sua fame del più basso, e scenda indipendente fino a che sia contento di scendere. – Ma in nessun punto raggiunto fermarsi lo accontenta e vuol pur scendere, ché il prossimo punto supera in bassezza quello che esso ogni volta tenga. E nessuno dei punti futuri sarà tale da accontentarlo (…) così che in ogni punto esso manca dei punti più bassi e vieppiù questi lo attraggono: sempre lo tiene un ugual fame del più basso, e infinita pur sempre gli resta la volontà di scendere. – Che se in un punto gli fosse finita (…) in quel punto egli non sarebbe più quello che è: un peso. La sua vita è questa mancanza della sua vita. Quando esso non mancasse più di niente, – ma fosse finito, perfetto: possedesse se stesso, esso avrebbe finito d’esistere. Il peso è a se stesso impedimento a posseder la sua vita e non dipende da altro che da se stesso in ciò che non gli è dato di soddisfasi. Il peso non può mai esser persuaso. (60)
E Simone: “La pesantezza fa scendere l’ala fa salire…”.
so che parlo perché parlo ma che non persuaderò nessuno…” e lo sa anche Simone quando rivolta alla sua amica scrive: “La tendenza a persuadere mi passa sempre di più”, e, ancora, quando Michelstaedter sa bene – e lo scrive nella prefazione – che non potrà essere ascoltato: “… i folli di Shakespeare e di Velasquez, proprio perché sanno la verità, non vengono ascoltati”. La metafora del peso “che pende e di-pende” ci avvicina, anche linguisticamente parlando, alle diverse schiavitù da dipendenza e ci illumina – meglio di tante elucubrazioni “cliniche”- su quella forma misteriosa di sofferenza tipicamente femminile che è la morte per fame, sul processo intimo che la governa e sulle difficoltà che s’incontrano nel corso di una cura. A quell’ insopprimibile bisogno d’Assoluto, a quella fame che a Carlo e a Simone fu concesso conoscere nel solo modo della mancanza, non c’è cura psicofarmacologica, né terapie adattive – cognitiviste e comportamentiste – che tengano. Non c’è cura che possa eliminare una sovrabbondanza di vita considerata anomala rispetto a dei parametri universali cui tutti/e dovrebbero uni-formarsi, ma occorrono spazi simbolici – angoli di terra, di cielo, di mare – in cui questo eccesso, questo “più” di vita trovi luogo, tempo e modo per essere ed esserci.
Ebbene, tutto ciò premesso, torniamo finalmente ai due enunciati di Weil – “Chi è sradicato sradica”, “Chi è radicato non sradica” – che ci siamo impegnati ad approfondire, ricordando, ancora una volta, che a caratterizzare vita e opera della nostra Lazare – così l’aveva soprannominata George Bataille – o della nostra Marziana “tutto cervello e sguardo – così la dipingeva il suo Maestro Alain – è un “radicalismo dominato molto in alto dalla Giustizia”. (61). A tornarci utile per evidenziare la mancanza di un anello fra il primo e il secondo enunciato tale da renderne comprensibile il nesso, è proprio il significato etimologico di questo termine “radicalismo”: “mettere le radici”. Se è vero, infatti, che “chi è sradicato sradica” è altrettanto vero che chi è sradicato va in cerca della radice ed è a un genere di radice molto speciale, finalizzata a quel Radicamento che è Dio, l’Assoluto, che Simone aspira e che le fa dire: “Chi è radicato non sradica”.
E’ importante tuttavia precisare che, per Weil, le due diverse tendenze – a sradicare e a radicarsi – proprie di chi è sradicato, nascono entrambe da una condizione di sradicamento che può evolvere in una direzione o nell’altra a seconda del significato non univoco (negativo o positivo), assunto, di volta in volta, da questo termine nei diversi contesti. Esiste infatti, per Simone, uno sradicamento che sradica – quello sradicamento “dal di fuori” che attraversa per intero l’ Enracinement – e uno sradicamento “dal di dentro” che radica, presente in altri frammenti, e che del Radicamento rappresenta, per così dire, il principio fondante. A parlarci di tutto questo in termini tanto complessi e a dissuaderci dalle semplificazioni, a parlarci di un certo tipo di sradicamento in termini di necessità, a operare, per orientarci, delle sofisticate distinzioni topiche fra uno sradicamento “dal di dentro”e uno sradicamento “dal di fuori”, a declinare e a connettere infine tutto questo con il termine decreation, è proprio Simone che se per un verso considera lo sradicamento e la sua capacità di moltiplicarsi la più pericolosa delle malattie:
Lo sradicamento è di gran lunga la più pericolosa malattia delle società umane, perché si moltiplica da sola. Le persone realmente sradicate non hanno che due comportamenti possibili: o cadere in un’inerzia dell’anima quasi pari alla morte (come la maggior parte degli schiavi dell’impero romano), o gettarsi in un’attività che tende sempre a sradicare, spesso con metodi violentissimi, coloro che non lo sono ancora o lo sono solo in parte. (62)
per un altro verso lo considera una necessità e persino un dono dell’amore di Dio:
E’ necessario sradicarsi. Tagliare l’albero e farne una croce, e poi portarla tutti i giorni. Sradicarsi socialmente e vegetativamente. Esiliarsi da ogni patria terrestre.
Fare tutto questo a un altro, dal di fuori, è un surrogato di decreazione. Significa produrre qualcosa d’irreale. Ma sradicandosi si cerca qualcosa di più reale. (63)
Se nella prima descrizione lo sradicamento viene inteso come malattia e il doppio effetto negativo da esso generato – inerzia mortifera dell’anima e violenza – rimandano al primo enunciato “chi è sradicato sradica”, nella seconda la comparsa del concetto di decreazione e lo specificarsi del suo significato in base alla topica del “dentro” e del “fuori”, modifica completamente il quadro di riferimento precedente e il senso del termine sradicamento. De-crearsi infatti è – rigorosamente – sradicarsi “dal di dentro”; essere sradicati “dal di fuori” è, invece, tutt’ altra cosa: un surrogato, e per di più colpevole, come vedremo fra poco, della de-creazione. Per facilitare la comprensione del concetto di de-creazione, allusivo, evidentemente, a un processo inverso a quello di creazione ma che assume, nei testi di Weil sfumature di volta in volta differenti, riporto tre definizioni esplicative suggeriteci da Weil ne L’ ombra e la grazia:
De-creazione in quanto compimento trascendente della creazione; annullamento in Dio, che dà alla creatura annullata la pienezza dell’essere, di cui è privata finché esiste. (64)
De- crearsi è ancora:
uscire dalla creazione e tornare al principio. (65)
Possiamo dunque intendere creazione e de-creazione come processi analoghi al fare e dis–fare. In effetti, l’operazione del disfare (deshacer), allusiva a quell’atto di auto-svuotamento (kenosis) necessario ad accogliere il Verbo, viene teorizzata e praticata anche da Maria Zambrano, un’altra importante figura mistica del ‘900, in Delirio e destino. A incombere su tutto questo, è però una domanda fondamentale: il processo di de-creazione-dis-facimento-retro-cessione-dis-nascita-de-soggettivazione o, come direbbe Lacan di destituzione – è una forma di distruzione? Il processo de- creativo è un processo che legittima una lettura nichilista della de-creazione?
La risposta di Simone è chiara:
Discreazione: far passare qualcosa di creato nell’increato. Distruzione: far passare qualcosa di creato nel nulla. Ersatz (surrogato colpevole della discreazione). (66).
La de-creazione non è la distruzione così come l’increato non è il nulla e la differenza qui evidenziata corrisponde in tutto e per tutto, alla differenza altrove teorizzata fra distacco e suicidio. A giocare un ruolo determinante in queste differenziazioni, è, ancora una volta, la topica esterno-interno utilizzata per distinguere le due diverse forme di sradicamento e che ritroviamo puntualmente e coerentemente evocata da Weil anche in riferimento all’io, quell’io, cui abbiamo accennato all’inizio, che deve essere distrutto per far posto a Dio.
Nulla è peggiore dell’estrema sventura che distrugge l’io dal di fuori, perché da quel momento non può più distruggersi da sé. (67)
Per contro:
Basta si sia iniziato il processo di distruzione dell’io per rendere innocua ogni sventura. Perché l’io non può essere distrutto da una pressione esterna senza una dura rivolta. Se ci si rifiuta a questa rivolta per amor di Dio, allora la distruzione dell’io non viene prodotta dal di fuori bensì dal di dentro. (68)
Ma il significato più profondo e più vicino al sacro di decreation, è presto svelato come la grande contraddizione che riguarda Dio e la sua creazione: Dio ha creato per essere amato ma non potendo creare qualcosa che sia Dio e dovendo creare qualcosa di differente da sé, non può essere amato da questo qualcosa che Dio non è. Ecco la contraddizione in cui si trova Dio e, a risolverla, non c’è che la grazia:
Dio crea un essere finito che dice io, che non può amare Dio. Per effetto della grazia a poco a poco l’io sparisce e Dio si ama attraverso la creatura che diventa vuoto, che diventa niente. Quando essa è sparita…egli continua a crearne e ad aiutarle a decrearsi. (69)
A rendere necessaria la sparizione dell’io per consentire alla “creatura pensante” di toccare “l’assoluto” e a Dio di toccare “il particolare”, è dunque la contraddizione di Dio. (70). Di qui la necessità di diventare “niente” e la “suprema pienezza” attribuita al vuoto. (71:
Dio, accordami di diventare niente. Nella misura in cui divento niente, Dio si ama attraverso me. (72
Ma è ne L’ombra e la grazia che il passaggio in mancanza del quale sarebbe difficile cogliere la connessione fra i due enunciati – quel nesso che ci ha fatto dire che chi è sradicato non si limita a sradicare ma va in cerca della radici – è il nesso che fa stare insieme, per dirla con Weil, “due contrari in uno”:
Assumere il senso di essere in patria mentre si è in esilio. Essere radicato nell’assenza di luogo. (73)
Che significa: essere radicati e sradicati al tempo stesso, essere contemporaneamente dentro e fuori. Si tratta di una posizione dolorosa tipicamente femminile, descritta in dettaglio in una Lettera di Weil a Padre Perrin durante il suo soggiorno a Marsiglia:
Orbene, io non voglio essere adottata in un ambiente, abitare in un ambiente dove si dice noi e far parte di questo noi, né sentirmi a casa mia in un ambiente umano quale che sia. Ma dicendo che non voglio, mi esprimo male, perché invece lo vorrei; sarebbe delizioso. Sento tuttavia che non mi è permesso. Sento che nel mio caso è necessario e s’impone che io sia sola, straniera o in esilio rispetto a qualsiasi ambiente umano, senza eccezioni. Questo sembra contraddire quanto le scrivevo a proposito del mio bisogno di fondermi con qualsiasi ambiente umano in cui mi trovi, fino a dissolvermi in esso; in realtà si tratta del medesimo pensiero: dissolversi in un ambiente non significa farne parte, e la capacità di fondermi con tutti implica che io non faccia parte di alcuno. (74)
“Essere radicato nell’assenza di luogo”, “essere in patria in esilio”: è forse questo genere di radicamento che a Carlo Michelstadter non è riuscito?
Pure io mi sento incorrotta e inesausta questa intima forza che mi spinge avanti, avanti – dove (…) che in nessun luogo mi spinge, ma mi strugge il cuore e m’allarga il petto e vuole, vuole vita. Dunque – perché? Che cosa c’è fra me e il mondo per cui sembra ch’io non possa mai attingerlo? (75)
E Simone, è davvero riuscita nella sua “follia mistica”, riflesso della “follia d’amore” di Dio? Ce l’ha fatta davvero la sua fame di Dio a non mettere “da parte la carne”, a gridare il “trascendente sensibile” (76) senza mettere a rischio la sua vita? A sfiorare i pensieri di Simone, c’è, fra i tanti, un interrogativo circa l’esistenza di un eventuale oscuro legame fra mistica e follia:
Si dice che i folli (quelli di un certo tipo) sono logici all’eccesso. Per un motivo analogo devono esserlo anche i mistici autentici. (77)
Il criterio delle cose che vengono da Dio è che esse presentano tutti i caratteri della follia, eccetto la perdita dell’attitudine a discernere la verità e ad amare la giustizia. (78)
Ed è ancora da lei che ci viene rivolto l’invito a interrogarci su questa analogia per sapere se esista:
un modo corretto di concepire lo studio della patologia mentale, che senza dubbio non è stato ancora concepito. (79)
Sono sempre stata riconoscente a Weil per la sua passione di andare fino in fondo, per l’onestà intellettuale e per il fatto di aver sollevato una questione ignorata che ha fatto da sfondo ai miei pensieri per tutto il tempo dedicato allo studio della mistica. Inutile dire che le diverse e persino opposte letture dell’opera di Weil – che si muovono cimentandosi in una specie di agone fra anarchismo e nuovo modernismo, fra tradizionalismo e conversione religiosa, fra gnosi e mistica, fra ontologia e antropologia – (80) sono il segno vivo della ricchezza di pensiero di questa grande donna. Non facciamoci dunque mancare, fra le tante interpretazioni, felici e meno felici, l’autorevole parere di Marco Vannini che di mistica se n’intende e che di questa indicibile esperienza scrive:
vera conoscenza dell’anima ed anche vera possibilità di terapia, apportatrice di salute nel senso fortissimo della salus… .(82)
E così, in questa epoché, in questa verità indecidibile, sospesa fra salute e follia, giusto ancora qualche flash, per finire e riaprire su una frase di Platone molto cara a Weil, contenuta nel Fedone: “Filosofare equivale a morire”. C’è un giudizio, impietoso, di Hanna Arendt – ma non solo – sulla filosofia di Platone e, più in generale, sulla storia della filosofia e sull’intimo legame che essa intrattiene con la morte:
Lungo tutta la storia della filosofia persiste l’idea davvero singolare di un’affinità fra la filosofia e la morte. (83)
Mi sono chiesta e mi chiedo, pensando a Simone e alla sua formazione – pensando a quella donna desiderosa di tenerezza che non ci mette niente a calcarsi sulla testa un casco e a scendere in miniera e per la quale essere nata donna, a leggere la descrizione di Bataille, ha rappresentato senza dubbio un castigo, – se la decreazione-vocazione di cui ci parla sia una filosofia della vita o una filosofia della morte. Mi sono chiesta e mi chiedo che parte abbia avuto nella sua tragica vocazione a de-crearsi – in cui la morte reale ha finito per trionfare su quella morte simbolica, propria del filosofo, descritta da Platone – il suo bisogno irriducibile di nutrirsi di “quel latte che è il seme del padre”. (24). Non tradisce forse, questo desiderio di nutrirsi di latte-seme paterno, un “attaccamento appassionato”, direbbe Butler, un’adesione esclusiva, totalizzante e acritica a un universo di pensiero e di sapere virili, a una tradizione filosofica-metafisica fallologocentrica che incentiva e produce, per stare in tema, uno sradicamento dalla propria origine materna e, con esso, il rifiuto di quel latte materno “avvelenato” di cui la sua biografia ci informa?
A sollecitarmi e a farmi dire tutto questo è un’esperienza d’ ascolto di molte donne, da molti anni, la cui sofferenza non è riducibile né riconducibile a mamma e papà, ma a un modo di stare al mondo che è frutto di una scelta impossibile il cui esito è, nel migliore dei casi, l’alienazione. Su questa faccenda della morte simbolica – dei cui effetti disastrosi ha finito per “beneficiare” anche la psicanalisi continuando a impartire, attraverso i suoi “Maestri” eredi di quello stesso sistema di pensiero, “formazioni” destinate a produrre cadaveri viventi – sarebbe davvero il caso di aprire un capitolo nuovo.
Fra un pro e un contro Platone scelgo in ogni caso, per chiudere, il Nonostante Platone di Cavarero che ben sintetizza il mio pensiero sul filosofo dell’iperuranio:
Platone si lascia derubare più facilmente da una donna perché è agevole sorprenderlo nell’atto del crimine filosofico che ha perpetrato sulle donne.
Occorre dirlo? Quando ad essere in giuoco è un “crimine filosofico” non posso non interrogarmi, se non altro per via di eredità e di parentele disciplinari, sui “crimini” psicologici e psicanalitici e non posso non chiedermi se sia davvero “meglio non guardare dove si va che andare fin dove si vede” (85) o se non sia doveroso guardare e sapere dove si è per sapere da che parte andare. Sulla necessità di una critica radicale e di una destrutturazione dell’intera filosofia occidentale – da Platone a Hegel, da Husserl ad Heidegger – sono impegnate da anni a livello nazionale e internazionale sulla scia di Arendt e Zambrano, Irigary, molte altre donne filosofe, teoriche del femminismo e non, che hanno fatto negli ultimi trent’anni un lavoro straordinario analizzando e denunziando nelle loro opere i pericoli devastanti cui conduce un sistema di pensiero erede di una filosofia dell’Uno.
Ma la tradizione filosofica con la quale dovrebbe operarsi il confronto teorico è preparata a questo passo? E’ possibile un’ altra filosofia, una filosofia dell’avvenire? E una psicanalisi dell’avvenire è possibile?
NOTE:
(1) Cfr. S. Petrémont, La vita di Simone Weil, Adelphi Edizioni, Milano 1994, p. 17
(2) S. Weil, Attesa di Dio, Adelphi Edizioni, Milano 2008, p. 33
(3) S. Weil, Quaderni, IV, Adelphi Edizioni, Milano 1993, p. 380
(4) S. Weil, L’ombra e la grazia, Edizioni Bompiani, Milano 2002, p. 77
(5) D. Canciani, Pensare la forza. Simone Weil dalla guerra di Spagna alla resistenza, DEP n. 12-14/2010, p. 189
(6) S. Petrémont, cit., pp. 544-45
(7) S. Weil, L’ombra e la grazia, cit., p.31
(8) S. Weil, Ibid., p. 57
(9) S. Weil, Ibid., p. 49
(10) S. Weil, Attesa di Dio, cit., p. 60
(11) S. Weil, Quaderni II, Adelphi Edizioni, Milano 1985, p. 193
(12) S. Weil, La prima radice, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 1990, p. 53
(13) Cfr. S. Weil, Attesa di Dio, cit., p. 54
(14) Cfr., S. Weil, Manifesto per la soppressione dei partiti, Castelvecchi Editore, Roma 2008, p. 60
(15) S. Petrémont, cit., p. 287
(16) S. Weil, Attesa di Dio, cit., pp.187-188
(17) S. Weil, La prima Radice, cit., p. 51
(18) Ibid., p. 70
(19) S. Weil, L’ombra e la grazia, cit., p. 181
(20) S. Weil, IV, Quaderni IV, cit., p. 336
(21) Ibid.)
(22) S. Weil, Quaderni, I, Adelphi Edizioni, Milano 1982, p. 386
(23) S. Weil, L’ombra e la grazia, cit., p. 9
(24) S. Weil, Quaderni, IV, Adelphi Edizioni, Milano 1993, p.119
(25) S. Weil, Ibid., cit., p. 337
(26)S. Weil, Riflessioni senz’ordine sull’amore di Dio, Edizioni Borla, Roma 1979, p. 113
(27) S. Weil, Quaderni II, cit., 1985, p. 37
(28) Ibid., p. 165
(29) M. Blanchot, L’infinito trattenimento, p. 143
(30) S. Weil, Attesa di Dio, cit., p. 78
(31) S. Weil, Ibid., p. 92-93
(32) Lettera di M.me Weil al marito del 21 Dicembre, S. Petrémont, La vita di Simone Weil, cit., p. 141
(33) S. Petrément, La vita di Simone Weil, Adelphi Edizioni, Milano1994, p. 557
(34) Cfr. S. Weil, Quaderni, IV, cit., p. 264
(35) D. Canciani, cit., p. 200
(36) S. Petrément, cit., p. 302
(37) S. Weil, Quaderni, IV, cit., p. 335
(38) S. Weil, L’ombra e la grazia, cit., p.75 sì
(39) S. Weil, Quaderni IV, cit., p. 264
(40) F. Nietzsche, La Gaia Scienza
(41) S. Weil, L’ombra e la grazia, cit., p. 67
(42) S. Weil, Ibid., p. 155
(43) S. Weil, Ibid., p. 215
(44) M. Vannini, La morte dell’anima, Casa Editrice Le Lettere, Firenze 2003, p. 298
(45) S. Petrément, cit., pp. 262-26
(46) Cfr., Ibid., p. 263
(47) M. Yourcenar, Mishima o la visione del vuoto, Gruppo Editoriale Fabbri-Bompiani, Sonzogno S.p.A., Milano 1982, p. 73
(48) S. Weil, L’ombra e la grazia, cit., p. 153
(49) S. Weil, Quaderni, IV, cit., p. 381
(50) Cfr. S. Pétrement, cit., p. 243
(51) C. Michelstaedter, La Persuasione e la Rettorica, Adelphi Edizioni, Milano 1982, p. 20
(52) S. Weil, Quaderni IV, cit., p. 385
(53) Ibid., p. 249
(54) S. Weil, Attente de Dieu, p. 209
(55) C. Michelstaedter, La melodia del giovane divino, Adelphi Edizioni, Milano 2010, p. 58
(56) Ibid., pp. 92-93
(57) C. Michelstaedter, La persuasione e la Rettorica, cit., p. 62
(58) S. Weil, Attesa di Dio, cit., p. 24
(59) M. Zambrano, L’uomo e il divino, Edizioni Lavoro, Roma 2008
(60) C. Michelstaedter, La Persuasione e la Rettorica, cit., pp. 39-40.
(61) S. Weil Manifesto per la soppressione dei partiti, Castelvecchi Editore, Roma 2008, p. 65
(62) S. Weil, La prima radice, cit., p. 52
(63) S. Weil, Quaderni, II, cit., p. 250
(64) S. Weil, L’ombra e la grazia
(65) Cfr., S.Weil, Quaderni IV, cit., p. 230
(66) S. Weil, L’ombra e la grazia, cit., p. 59
(67) S. Weil, L’ombra e la grazia, cit., 49
(68) Ibid.
(69) S. Weil, Quaderni II, cit., p. 291 si
(70) Cfr. S. Weil, Quaderni III, Adelphi Edizioni, Milano 1988, p. 32-33
(71 Ibid., p. 238
(72) Ibid., p. 37
(73) S. Weil, L’ombra e la grazia, cit., p. 71
(74) Weil, Attesa di Dio, cit., p. 15-16
(75) C. Michelstaedter, La melodia del giovane divino, cit., pp. 58-59
(76) Cfr., S. Petrémont, cit., p. XXIV
(77 ) S. Weil, Quaderni IV, cit., p. 166
(78) Ibid., p. 383
(79) S. Weil,
(80) A. Del Noce, Simone Weil, interprete del mondo di oggi in L’amore di Dio, Edizioni Borla, Roma 1979, pp. 9-10
(81) M. Vannini, Le origini della mistica, 2003, p. 20
(82) H. Arendt, La vita della mente, Il Mulino, Bologna 2009, p. 162
(83) H. Arendt, Lettera della Arendt a Jaspers, 4 marzo 1951, in Carteggio, Feltrinelli, Milano 1989, pp. 104-106
(84) C. Michelstaedter, Il dialogo della salute, Adelphi Edizioni, Milano, 1988, p.84
(85) Ibid., p. 113
(86) S. Weil, L’ombra e la grazia, Edizioni Bompiani, Milano 2002, p. 93
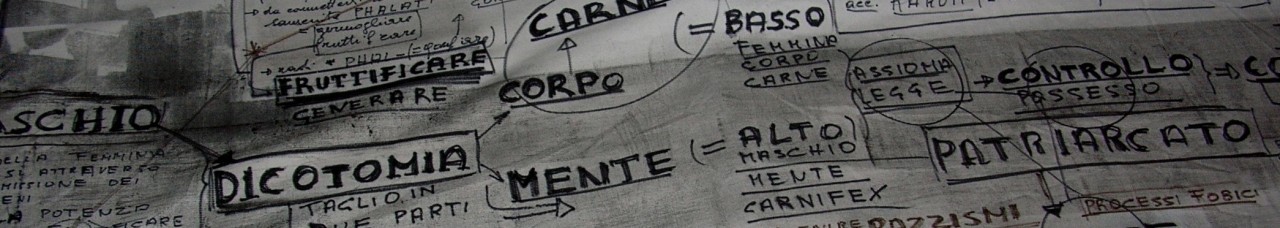

Lo leggerò attentamente, quando avrò il tempo e poi te ne dirò. Gian Andrea