Di Paola Zaretti / Vittime ideologiche
Ridurre il dominio a una semplice relazione fra chi agisce e chi subisce significa sostituire all’analisi l’indignazione morale. Per di più, una tale semplificazione riproduce la struttura della polarizzazione di genere laddove ci si proporrebbe di smantellarla. (Jessica Benjamin)
Ecco, se vogliamo comprendere a che cosa Benjamin si riferisca quando lancia la sua critica nei riguardi di un’idea di dominio ridotto a “indignazione morale” e quando allude a una “semplificazione” di questo concetto destinata a riproporre la stessa struttura polarizzante che si vorrebbe smantellare, abbiamo qui un esempio che fa al caso nostro. Leggiamo, infatti:
Con colpevolizzazione della vittima si intende quell’ atteggiamento assunto da chi ritiene la vittima di un crimine o di altre sventure parzialmente o interamente responsabile di ciò che le è accaduto: questa interpretazione della vicenda si accompagna al tentativo di indurre la vittima stessa ad autocolpevolizzarsi.
Secondo questa lettura decisamente semplificata e puramente ideologica, la “vittima” non solo dovrebbe essere sempre e comunque esonerata da qualsiasi responsabilità – parziale o totale che sia – in ciò che le accade, ma il fatto stesso di riconoscerle una qualche parte di complicità (sia pure inconscia, involontaria) in ciò di cui si lamenta, sarebbe un tentativo per indurre la vittima all’autocolpevolizzazione!!!! Noi crediamo, invece, che considerare la “vittima” alla stregua di un oggetto passivo esposto alla totale mercè di un altro, sia il segno tangibile e manifesto di una assoluta mancanza di considerazione nei suoi riguardi e nei riguardi delle sue capacità re-attive, attive e, infine, liberatorie.
E’ dunque grazie a questo genere di visione – puramente ideologica – che quel processo di ri-vittimizzazione – contro cui si crede di combattere – può aver luogo. E allora vien da chiedersi che fine abbia fatto, in questa visione, l’autocoscienza.
Leggere a questo proposito
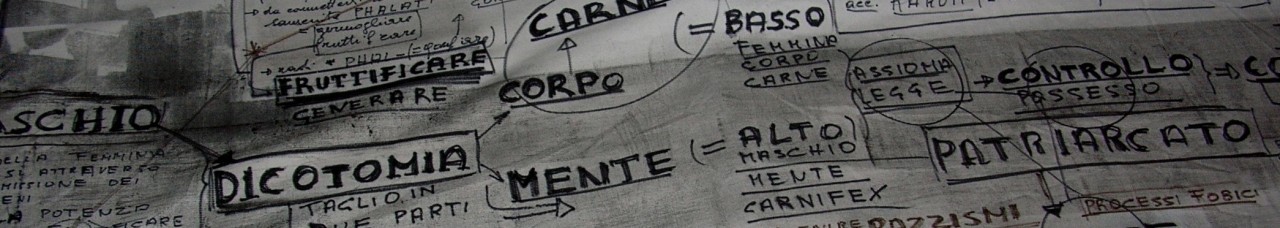

Visto che questo post nasce da un mio post su facebook (https://www.facebook.com/ilricciocornoschiattoso/posts/933064473420288) ci tengo a rispondere.
Il concetto di colpevolizzazione della vittima è stato coniato dallo psicologo William Ryan che nel 1971 scrisse “Blaming the victim“, in risposta al saggio di Daniel Patrick Moynihan “The Negro Family: The Case for National Action” del 1965.
La teoria di Moynihan sosteneva che tre secoli di orrori perpetrati dai bianchi – con particolare riferimento alla schiavitù – avessero distrutto la struttura della famiglia di colore lasciando il caos: nascite al fuori del matrimonio, padri assenti, madri single, queste erano secondo Moynihan le cause del basso tasso di occupazione, del basso livello di scolarizzazione, della povertà; come soluzione proponeva che il Governo si impegnasse a rendere più solido il nucleo familiare, affinché tornasse ad essere la base su cui fondare una solida comunità nera. In parole povere: erano i neri che dovevano cambiare, loro gli unici a doversi impegnare per produrre un miglioramento nella loro vita.
Ryan obiettò che non era nel comportamento dei singoli cittadini di colore che andava ricercata la causa della loro povertà, del basso livello di scolarizzazione o delle difficoltà a trovare un impiego, ma che questi problemi affondavano le radici nella struttura della società analizzata nel suo complesso: una società che relegava le persone di colore ai margini, deprivandole degli strumenti necessari a vivere in maniera differente.
Se siamo d’accordo sul fatto che anche le donne costituiscono nella società contemporanea una categoria discriminata, non è difficile comprendere perché il concetto di “blaming the victim” può essere applicato anche alla violenza di genere senza per questo sminuire la dignità delle singole vittime. Anzi, a maggior ragione, perché la violenza di genere è violenza perpetrata da quella parte di popolazione che gode di privilegi nei confronti di chi è posta ai margini.
Siamo immerse – tutte – in una cultura misogina che sin dalla più tenera età ci impone una ben precisa identità di ruolo basata sul sesso biologico: l’uomo è quello forte e volitivo, la donna è quella tenera e accudente.
Ci viene insegnato ad accettare la violenza come inevitabile corollario dell’amore (http://blog.pianetadonna.it/leggerezza/non-sempre-anzi-solito-ero-figlio-puttana/) perché l’aggressività è nella natura dell’uomo.
Limitare l’analisi della violenza nelle relazioni sentimentali alla psicologia degli individui coinvolti, trascurando il contesto culturale, questo si, è riduttivo. Inoltre, a cosa è utile, nel momento in cui vado a narrare un caso di violenza come quello che riportavo nel mio post, (una ragazzina di 15 anni pestata dal fidanzato perché gli ha comunicato di essere incinta) l’accanimento sulla ragazzina? Pensate forse che rimproverarle di non aver colto quei segnali che potevano allarmarla nei confronti del suo partner (sengali che la nostra società ci insegna ad accettare come pegni d’amore, basti pensare alla gelosia, alla possessività) possa aiutarla a rimpolpare la sua autostima? Di che cosa vogliamo accusare una quindicenne? Di non essere in grado di decostruire gli stereotipi di genere? A 15 anni?
Siamo così d’accordo sul fatto che le donne rappresentino una categoria discriminata, che la nostra costante e dura critica al Patriarcato – testimoniata da scritti, articoli recensioni, saggi recenti e non – è quanto basta e avanza a darne conto.
L’analisi di cui si tratta – che fa preciso riferimento ad alcuni passaggi cruciali del testo di una psicanalista femminista (Jessica Benjamin) nonché alla mia personale esperienza di trentacinque anni di lavoro con le donne – non solo non è limitata “alla psicologia degli individui coinvolti” che pure è e resta della massima importanza, ma tiene nel dovuto conto il contesto culturale da cui non può, evidentemente, essere scissa. E ne tiene conto nella misura in cui è precisamente in quel contesto culturale “patogeno” e discriminante – come da lei stessa del resto evidenziato quando scrive: “siamo immerse – tutte – in una cultura misogina che sin dalla più tenera età ci impone una ben precisa identità di ruolo basata sul sesso biologico: l’uomo è quello forte e volitivo, la donna è quella tenera e accudente” – che una donna è indotta ad “imparare” e a interiorizzare la sottomissione, la subalternità, la servitù, la dipendenza.
In merito ad altre sue affermazioni, la frase è stata riportata, esattamente così come compariva in fb senza l’intero post cui lei fa riferimento.
Mi preme dirle, in ogni caso e al di là di questo, che i “rimproveri” nei riguardi della ragazzina non sono contemplati né nella nostra funzione né nella nostra formazione e che, diversamente da lei, siamo lontanissime dall’illusione che per essere d’aiuto a una donna un “rimpolpo” di autostima sia sufficiente a risolvere un problema di dipendenza (magari fosse così semplice!!).
Infine, le accuse immaginarie nei riguardi della ragazzina – da noi mai espresse e da lei attribuiteci e con quanta inutile enfasi!!! – sono unicamente frutto della sua fantasia.
L’arma più potente nelle mani degli oppressori è la mente degli oppressi, diceva Steve Biko.
E in questo senso – poiché tutte le oppressioni si basano sui medesimi schemi comportamentali – posso parlare di un certo tipo di “corresponsabilità”. In senso molto lato, però, perché nessuno merita di subire violenza, ed è eticamente scorretto scaricare sulla vittima la responsabilità di qualcosa che non agisce, ma è costretto a subire.
In che modo la mente dell’oppresso è un’arma nelle mani dell’oppressore? E’ semplicissimo: l’oppresso è convinto di meritare il ruolo di sottomesso nel quale l’oppressore lo relega. Questo lo si comprende appieno andando a studiare le forme più estreme di oppressione, nelle quali determinati meccanismi – proprio perché esasperati – diventano palesi.
Ci sono studi interentassimi sulle strategie elaborate nei campi di concentramento nazisti, grazie alle quali si cercava di limitare l’uso della brutalità da una parte (che comunque comporta un costo, in termini economici) e di sostenere la motivazione dei carnefici dall’altra.
Sarebbe interessante parlarne, e magari spiegare perché si fa il gioco del carnefice sostenendo che la vittima deve riconoscersi responsabile della violenza in quanto individuo, ma non amo discutere con gente che invece di proporre delle argomentazioni pensa di intimidire l’interlocutore snocciolando il suo curriculum, un espediente imbarazzante, davvero.
Come vede, non siamo poi così distanti ma forse non c’era bisogno, per un approccio di questo tipo, di Steve Biko, Freud e non solo lui, basta e avanza.
Che nessuno/a meriti di subire violenza, come lei dice, è fuori dubbio, per non dire scontato.
Devo inoltre sottolineare che, diversamente da quanto lei afferma, non esiste un solo punto nei nostri scritti in cui la responsabilità venga “scaricata” sulla vittima che mai è stata considerata isolatamente e al di fuori della coppia vittima-carnefice, di chi agisce e di chi subisce.
Andrebbe peraltro precisato – ma chissà mai come verrebbe equivocato!!! – che persino il subire richiede una certa dose di attività.
Ho avuto modo di conoscere, grazie al dono di un’amica autrice di diversi libri sull’argomento, le strategie utilizzate nei campi di concentramento cui lei allude.
Vero, concordo con lei, sarebbe interessante parlarne ma impostando il problema correttamente e diversamente da come lei insiste a fare nell’attribuirci, di nuovo, affermazioni mai sostenute del tipo
che “la vittima deve riconoscersi responsabile della violenza in quanto individuo” e già in precedenza smentite in uno dei nostri commenti in cui individuale e sociale-culturale appaiono inscindibili.
Ciò che costantemente ritrovo, in quanto scrive e in questi commenti, è quel vizio di fondo che cerchiamo di combattere: l’incapacità di guardare a due realtà SIMULTANEAMENTE invece che oppositivamente.
E’ un vizio della cultura occidentale la cui viziosità porta a un circolo vizioso frustrante ma difficilissimo da sradicare. Di qui equivoci e incomprensioni che caratterizzano le discussioni in cui non si viene mai a capo di nulla.
Voglio anche ricordarle che di argomentazioni e di analisi precise e circostanziate i saggi pubblicati abbondano. Quanto, infine, ad un supposto desiderio di “intimidire l’interlocutore” con lo snocciolamento del “curriculum” (ma non si riferirà mica, per caso, ai trent’anni e più di lavoro con donne?) non me ne voglia se le dico che dal serio al faceto non c’è che un passo. Anche perché, il tenore dei suoi commenti non rivela certo timidezza. Il punto essenziale in tutta la faccenda è questo e glielo segnalo:
“Anche le teoriche femministe più sofisticate spesso si ritraggono davanti all’analisi della sottomissione per timore che, riconoscendo la complicità della donna nella relazione di dominio, il peso della responsabilità possa spostarsi dagli uomini alle donne e la vittoria morale dalle donna agli uomini”. (Benjamin)
Qui sì c’è timore, un timore che purtroppo condiziona e limita pesantemente proprio la possibilità di un’analisi profonda sul dominio maschile.
Un ringraziamento per i suoi contributi
Quello che forse ignorate, è che nelle relazioni sentimentali viziate dalla violenza, è tipico del partner violento scaricare la responsabilità della violenza sulla vittima che subisce, ed è questo che tiene insiene la vittima e il suo carnefice. La vittima è convinta che è suo comportamento a scatenare gli eccessi di violenza – perché è questo che lui le racconta – e tenta disperatamente di assumere un comportamento atto ad evitarla. E’ nel momento in cui la vittima si rende conto che qualsiasi atteggiamento non la preserverà dalla violenza, che l’unico modo per sopravvivere è allontarsi dal partner violento, perché non esiste un comportamento che possa tutelarla, che si libera ed è salva.
Parlare ad una vittima di violenza delle sua responsabilità significa parlarle la lingua del suo aggressore.
La violenza non scaturisce dalla relazione, ma dal convincimento del violento che l’esercizio del controllo e del potere sulla partner è legittimo, e questa convinzione gli viene dal fatto di vivere in una società patriarcale.
Un uomo violento è violento con tutte le sue partner: gli schemi che mette in atto con donne diverse fra loro sono sempre i medesimi.
Allora perché perdere tempo a studiare la vittimologia, quando è chiaro che basta essere donna per essere vittima di violenza di genere?
Che il problema non è psicologico, ma il problema è il patriarcato?
Noi certamente ignoriamo un’infinità di cose e non potrebbe essere diversamente. Ma conosciamo bene il nostro lavoro. Non sappiamo che lavoro lei faccia e da quale posizione si permetta di formulare giudizi del tipo: “Parlare ad una vittima di violenza delle sua responsabilità significa parlarle la lingua del suo aggressore”. No, gentilissima: parlare ad una vittima di violenza delle sue “responsabilità”, significa parlare la lingua di chi la considera non un oggetto ma un soggetto pensante capace di analizzare in profondità anche i propri comportamenti e il ruolo che essi hanno in una determinata situazione. Decidere come utilizzare il nostro tempo è affar nostro ma è certo che tra l’impiegarlo in frasi fatte che eludono il nesso – che evidentemente le sfugge – fra il patriarcato e gli effetti psichici devastanti da esso indotti su donne e uomini, diamo la priorità al secondo.