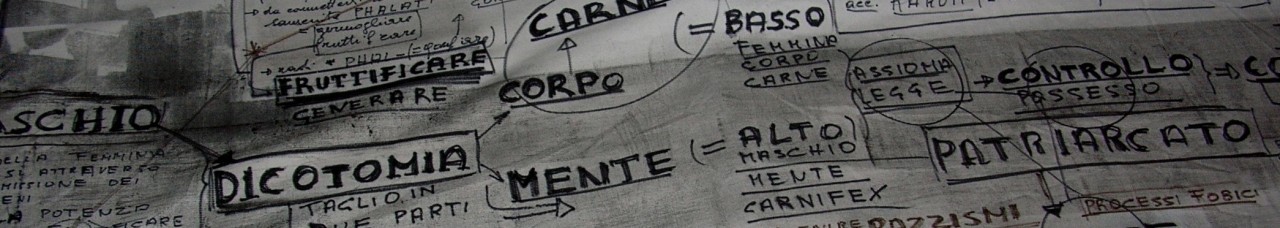Eccoci qua… di nuovo insieme al nostro secondo appuntamento che ha per titolo Conversando a partire da altre a partire da noi, per confrontarci su un tema decisamente arduo e impegnativo: sul nostro modo di intendere e sul senso da dare a due enunciati di Angela Putino dall’apparenza semplici, fatti di poche scarne parole piene di senso – bastanti a se stesse anche fuori da qualsiasi contesto – che raccolgono il distillato del suo pensiero in tema di relazioni fra donne e una preziosa indicazione filosofica, pedagogica, psicologica, etica e politica rivolta alle donne su come intendere, vivere e praticare delle salutari relazioni fra loro. E’ di Parole – di Parole dense e piene di senso di una pensatrice del suo calibro – che si avverte, oggi, in tempi di povertà, l’urgenza, anche in considerazione del fatto che, salvo poche eccezioni, quanto si va dicendo e scrivendo attorno al tema della “relazione”, non fa che svelare l’incapacità di uscire dall’impasse di una ripetizione sempre più esangue, vacua e inconsistente.
Gli enunciati, scelti fra i tanti – un appello a un dover-saper essere, il primo – un sofferto richiamo a una condizione ontologica sperimentata sulla propria pelle e l’invito a superarla, il secondo – sono i seguenti:
La guerra si fa talvolta perché c’è una straniera. Dovremmo saper esser tra noi straniere senza distanze, senza indifferenze e vicine senza identificazioni. (Putino, Arte di polemizzare tra donne)
Spesso tra donne si vive una fusione senza separazione: una sorta di indiviso. Tutto quello che non mantiene uno stato di uguaglianza viene privato di esistenza: così paradossalmente nell’indivisione si ha diritto di esistere e nel distinguersi si viene cancellate. (Ibid.)
A fare da sfondo alla nostra Conversazione e agli enunciati di Angela, sensibile a quell’ “impersonale” – un altro modo per lei di nominare l’inconscio – c’è anche il pensiero di un’altra donna, Antoniette Fouque, una psicanalista francese la cui influenza sul femminismo italiano è nota e per la quale tener conto dell’inconscio era il solo modo, per il femminismo, di evitare il delirio:
Mi sembrava che se non avessimo tenuto conto dell’inconscio, presto avremo navigato in pieno delirio.
Angela, a giudicare da alcuni suoi scritti, teneva l’inconscio in grandissimo conto e le parole di Antoniette sono il fosco presagio del delirio in cui siamo dentro fino al collo quando pensiamo, ingenuamente, di poterlo liquidare e archiviare come ha fatto il femminismo a partire da una certa fase storica e come pare continui a fare. Prenderemo spunto per la nostra Conversazione dai primi due enunciati di Angela, sapendo in anticipo che un’idea più precisa sulla vastità e profondità delle questioni sollevate – il cui valore oltrepassa la teoria e la pratica femminista per includere altri saperi disciplinari (dalla filosofia, alla psicanalisi, alla mistica) – emergerà, e solo in minima parte, al termine di questa Conversazione. Non ci resta dunque che cominciare dal primo enunciato chiedendoci:
Che cosa significa, in una pratica di relazione fra donne “essere straniere senza distanze”? Che cosa significa “essere vicine senza identificazioni? Che rapporto c’è fra queste due posizioni? Si tratta di due posizioni femminili soggettivamente diverse o di due differenti modalità di descrivere una sola e medesima posizione? Ciò che possiamo immediatamente rilevare all’interno del primo enunciato, è la presenza di due coppie di contrari: vicinanza-distanza, estraneità-identificazioni. Inoltre, un elemento che nella prima coppia ci colpisce, è che il termine scelto da Angela per indicare l’opposto della parola vicinanza, non è lontananza – come ci si potrebbe aspettare – ma distanza che conserva, tuttavia, la stessa accezione negativa. Possiamo osservare, ancora, che il concetto di distinzione contenuto nel secondo enunciato non allude a una distanza ma a una differenziazione, a una divisione, a qualcosa, insomma, che possiamo anche indicare con il termine separazione, parole che hanno dunque per Angela lo stesso significato. E poiché Angela non era una donna che usava le parole senza valutarne il peso e il valore significante, la scelta di alcune piuttosto che altre, è per noi un’utile guida. Vado ora a considerare il secondo enunciato: Nell’indivisione si ha diritto di esistere e nel distinguersi si viene cancellate, per sottolineare la presenza di un’altra parola, indivisione, che Angela qui introduce allo scopo di trasmettere il suo pensiero critico circa il criterio di riconoscimento, all’interno del femminismo, del diritto di esistenza conferito a una donna da parte di altre: si tratta, a ben vedere, di un diritto che le viene riconosciuto solo a condizione di un sua omologazione alle altre (indivisione) mentre tale diritto le viene negato nel caso di una sua differenziazione dalle proprie simili. In altre parole, ciò che Putino ci racconta, è che nelle “idilliache” relazioni fra donne, omologazione, indivisione e indistinzione sono le regole dominanti mentre la divisione, la differenziazione, la distinzione, la separazione vengono trattate come “reati” punibili con l’esclusione e l’isolamento. Il riconoscimento del diritto a esistere è dunque il premio elargito dalle donne alle donne piegate all’asservimento di una indifferenziazione omologante. Sono premi e castighi ad abitare lo scenario inquietante disegnato da Putino, uno scenario che non fa certo onore al femminismo con cui, in anni ormai lontani, lei era ad un certo punto entrata in contatto: un femminismo lontano dall’idea che lei ne aveva e lontano dall’aver compreso e maturato all’interno delle pratiche di relazioni in uso, la complessità e la sfida lanciata dai suoi enunciati. Una sfida persa contro l’interiorizzazione e la riproposizione, all’interno del femminismo della differenza, della logica maschile delle opposizioni e delle sue pesanti conseguenze sul piano della costruzione di Sane e vivibili relazioni fra donne. Il tentativo di Angela – fare in modo che le donne cessassero di essere, fra loro, o nemiche o sorelle, o straniere con distanza o vicine con identificazioni, è fallito com’era fallito, per ragioni diverse, quello di Lonzi. Quello che dobbiamo chiederci è se pensiamo che oggi le cose siano diverse, se il traguardo auspicato da Angela – la capacità di vivere fra donne delle relazioni sane e impostate sui presupposti da lei indicati – si sia realizzato oppure no.
Paola: La prima cosa che mi è venuta in mente quando ho letto questi pensieri di Angela, è il titolo di una relazione preparata per un incontro a Milano al quale fui invitata, anni fa, da una cara amica Valeria Medda, una donna dalla grande mente che purtroppo non c’è più. Il titolo era: L’odio lega l’amore separa. Ecco, a me pare che Angela, pur non facendo qui esplicitamente cenno all’amore e all’odio, li contempli implicitamente nei suoi enunciati. Che cos’è l’amore se non l’inverso di quell’illusione identificatoria e mortifera – fare di Due Uno – che comporta l’incorporazione e la distruzione dell’oggetto amato? Che altro è se non l’arte di vivere quella vicinanza senza identificazione, quell’estraneità senza distanza di cui ci parla, in virtù delle quali eliminazioni e cancellazioni non avrebbero luogo ad essere? Non è forse l’odio l’esito funesto di un’identificazione – sempre, per sua natura, ambivalente (Freud) – capace di regredire fino al punto di mancare il legame con l’oggetto e di sostituirsi ad esso introiettandolo, divorandolo, facendolo insomma sparire? (Freud). Sono questi i pericoli legati ai meccanismi identificatori – rilevati da Putino – in cui le relazioni fondate su una vicinanza sostenuta da un’identificazione, si distruggono e si consumano nella rottura.
Domanda: Hai appena introdotto la parola “rottura”, facendo esplicito riferimento alla rottura di un legame. C’è differenza per voi fra la rottura di un legame e la separazione, la distinzione, la divisione – per riprendere i termini di Putino – da un legame? Fra la modalità, inevitabilmente violenta, della rottura e la ricerca di una salutare distanza?
Paola: La rottura di un legame, la rottura violenta, la scissione è l’esatto inverso di un processo di separazione, di distinzione e di divisione. La rottura è la distanza e non contempla quell’ elaborazione della perdita e quel lavoro del lutto che dovrebbero seguire a una morte o allontanamento da una persona amata, non permette di attuare quella separazione che mira a un’estraneità senza distanza e a una vicinanza senza identificazione di cui Angela ci parla. La rottura indica un’impossibilità di separazione e di avviamento e compimento del lavoro del lutto – il lutto innanzi tutto di sé – che permettono di ritrovare l’altra/o su un altro piano, sul piano di un amore non patologico, sul piano della possibilità di conservazione di una relazione umana e civile. Alla differenza fra rottura, scissione come “falsa pista”, e separazione ci parla Kristeva quando scrive:
Le strade per giungere al distacco divergono: la scissione è una falsa pista; la depressione che viene dopo la separazione/morte conviene molto di più. (Julia Kristeva, Melanie Klein, La madre, la follia)
Leda: Credo di aver bisogno di un po’ per riordinare il fiume di pensieri che tale riflessione porta alla mia presenza. La prima domanda che mi viene in mente è inevitabilmente legata ad una mia esperienza: se la rottura non significa separazione, rompere nel senso di porre fine ad una frequentazione significa andare oltre al rapporto in questione o significa solo interromperlo, lasciarlo lì per così dire, irrisolto, e ricominciare da capo? Credo di aver agito così per molto tempo, riproponendo quel rapporto irrisolto o quei rapporti irrisolti con varie persone che ho incontrato nel mio cammino. Credo anche di stare riuscendo a risolvere questi rapporti e a scoprire pian piano la mia posizione ovvero ciò che corrisponde al mio essere autentica ma… il rischio dell’identificazione è sempre presente e ora, invece di un tempo in cui lo cercavo, mi genera angoscia, ad esso è molto legato il mio rapporto con la maternità, poiché il rischio della simbiosi accresce enormemente in questa esperienza, anzi, forse, è una fase inevitabile. Il rapporto simbiotico ha occupato larga parte della mia vita e ora l’idea di ritrovarmici dentro mi terrorizza ma… c é altro. Mi è difficile, molto difficile, capire dove sono io in rapporto a quello che definisco tra me e me, in questo periodo, il mio “marchio”. Io sono stata marchiata, ho preso una forma particolare, come credo ognuna di noi, in base all’equilibrio psico-fisico in cui sono nata, all’equilibrio di mia madre in relazione a sé e al resto della famiglia. Ho preso la forma del suo bisogno ed ora mi rendo conto di essere bravissima a prendere la forma del bisogno altrui, anzi, la mia è quasi una necessità, senza il bisogno altrui fatico a prendere una forma che posso definire mia anche perché non ho mai creduto a qualcosa di vero che mi appartenesse, ad una forma stabile che potessi essere io a meno che non si parli di corpo, qui ed ora. Ma questa è simbiosi? Non credo che in sé lo sia ma credo che questa mia tendenza debba essere gestita in modo tale che non diventi simbiosi. La frase di Putino evoca un continuo processo, un andamento temporale, forse in questo andirivieni di vicinanza e separazione, rompere nel senso di porre fine ad una frequentazione significa andare oltre al rapporto in questione o significa solo interromperlo, lasciarlo lì per così dire, irrisolto, e ricominciare da capo? Romperlo non vuol dire risolverlo, la risoluzione è, per Putino, nella separazione non nella rottura.
Lorella: Difficilissimo! Ci devo pensare un po’ perché finora il mio vissuto è “separazione=rottura”, almeno sul piano emotivo anche se fisicamente può permanere la vicinanza…Per questo sostenevo che questa frase è difficile da applicare! Richiede probabilmente una capacità di non lasciarsi coinvolgere cosi a fondo da una relazione e l’identificazione, la vicinanza la implica forse perché il legame che si stabilisce con le persone impone uno o più aspetti in cui ci si trova in sintonia. L’equilibrio tra vicinanza e distacco, in questi termini, è decisamente arduo. Mi pare riecheggi qualcosa di simile alle filosofie orientali!!!
Rossana: Le parole di Putino, assieme alle vostre, mi hanno portata a chiedermi: da dove partire? Ecco, il “dove” è stato l’appiglio che mi ha fatto immaginare una metafora geografica, che parte proprio dalla parola “straniere”. La prima cosa che mi ha colpito nelle citazioni, è che Putino ci invita ad esserlo, straniere, ma fa un passo in più: ci invita a “saper essere” tali. Penso che questo sapere abbia a che fare con la consapevolezza di sé, ossia la consapevolezza che siamo straniere innanzitutto a noi stesse, che in noi alberga una sconosciuta con tutto ciò di estraneo e rimosso ci appartiene. Esserne consapevoli implica l’aver accesso all’inconscio, nostro e altrui, riconoscendolo come fonte di conflitti ma soprattutto di sapere di sé, quindi di ricchezza, che consente di stare con altre donne, pur confliggendo, ma senza farsi la guerra. Oltre a tutto ciò che avete già ben descritto, inoltre, straniere indica anche lo stato di appartenenza ad una terra, ad un luogo di origine differente. Quale geografia ci propone, quindi, Putino? L’elemento cruciale è che tra terre vicine esiste un “confine”, una segno che de-limita, separa e distingue. Riconoscere il proprio essere straniere l’una rispetto all’altra significa secondo me riconoscere questo confine, ossia che ciascuna non solo possiede e appartiene ad una propria terra, ma che è in sé terra. Il confine non appartiene ad alcuna ma è di entrambe le parti, un ”luogo per tutte e per nessuna”, il luogo del legame e della relazione, tra due e tra più di due. E la qualità che assume questo limite permette il passaggio, e lo scambio, di parole, gesti, sentimenti, atti. Seguendo il tragitto di Angela, se questo confine diventa una distanza, l’immagine è quella che tra l’una e l’altra si apra un baratro senza fine, uno strapiombo che impedisce qualunque possibilità di incontro: l’altra non è più raggiungibile, ogni richiamo cade nel vuoto e non esiste più possibilità di contatto. Ecco, questo credo sia la “rottura”: una frattura nel terreno, una spazio che, per quanto piccolo, diventa incolmabile perché tra l’una e l’altra non passa più nulla. Silenzio, o parola vuota. Diversa è, come dice Paola giustamente, la lontananza, perché anche se siamo lontanissime, il nostro confine ci tiene comunque in contatto. E non ci perdiamo di vista. Cosa accade invece, se il confine non c’è? Succede che abitiamo un unico territorio, indiviso, chiuso, serrato in pace purché esistiamo indistintamente, senza dislivelli, tanto da non sapere più chi sono io e chi sei tu, uguali, interscambiabili, in-esistenti. Parliamo la stessa lingua e usiamo le stesse parole, che rischiano di svuotarsi di senso. Siamo nella simbiosi, funzionale alla sopravvivenza di entrambe. Fin qui la geografia è piatta. Cosa succede se la propria terra prende corpo, sporge, ha forme che creano panorami diversi, vette, fiumi, verde rigoglioso… ossia se ci si distingue? Nel momento in cui esprimo la mia posizione differente, la mia estraneità, pongo una frontiera e, sancendo la sua esistenza, compio un atto di cesura, rompo il sigillo all’uniformità, attivando in tutte, accanto alla possibilità e al desiderio di distinguersi a propria volta, la resistenza a farlo per paura di dis-perdersi ognuna per conto proprio. E l’angoscia di impazzire è a pochi passi perché oltre che straniere l’una per l’altra, costringe a riconoscere che uscendo dall’indistinto siamo straniere a noi stesse. Delirare, d’altronde, è uscire da sé, dal proprio solco. Che fare allora per annullare questa angoscia? Le vie che Putino sembra indicare sono due: o si considera “corpo estraneo” colei che si distingue e la si espelle semplicemente cancellandola. Oppure, se ciò non è possibile, non si fa che cancellare la differenza, misconoscendo il confine e provocando perciò lo s–confinamento identificandosi con l’altra ambita e pervertendo la relazione. Tu, terra rigogliosa e fertile non devi esistere, che invidia la tua creatività! Allora faccio mio il tuo buono, mi radico in te, cresco succhiando il tuo nutrimento, ti s-frutto e distruggo, espellendo in te miei rifiuti. Nel frattempo la mia terra si desertifica e non posso più tornare a mani vuote. Siamo in un gioco di specchi, fatto di introiezioni e proiezioni, spesso reciproche. Ecco, credo che Angela ci inviti, piuttosto, a coltivare la terra che siamo, la nostra ‘identità’, a radicarsi, come lei dice, in noi stesse, e per far questo abbiamo bisogno della vicinanza di altre donne che ci attraversano l’esperienza, dentro cui transitiamo, nomadi, ricevendo da loro semi da far fruttare in noi se il nostro terreno è compatibile, ma smettendo di piantare radici altrove, così a nostra volta potremo diventare terre feconde, ossia creati: senza bisogno di guerre di conquista e depredazioni.
Paola: Hai introdotto un termine importante, Rossana: perversione: “pervertendo la relazione”, hai detto, e preciserei che la perversione a cui Freud assegna un posto assai singolare, anomalo, per certi versi, rispetto alle altre categorie cliniche tradizionali (nevrosi e psicosi), va qui freudianamente inteso, privo cioè da valenze di tipo moralistico trattandosi, piuttosto, di una “malattia dello spirito”. Importante anche la sottolineatura del significato del termine “delirare” inteso nel senso di uscire dal proprio solco, insomma, deragliare. Delirare è deragliare.
Maria: Provo a tradurre il pensiero di Angela Putino. Straniera: io mi sento diversa da te per posizione culturale, sociale ma questa diversità non è tale da tenerti distante da me per paura di confronto, di giudizio, di contaminazioni, ma tale da stabilire quella “giusta distanza” che mi consenta di incontrarti per conoscere e riconoscere il tuo sapere, le tue competenze, per condividere le tue/i tuoi idee/ideali e gradualmente sentirti/mi vicina: provare reciproca risonanza e consonanza in molte sfaccettature esperienziali. Vicine: In sintonia perché scopriamo di avere tante “cose” in comune, vicine ma senza sussumere la tua identità: senza fondermi e confondermi in te, sentirmi parte/partecipe dei tuoi progetti senza appartenerti, senza completarti; orientate al raggiungimento di alcuni obiettivi, procedendo sullo stesso binario dove le rotaie stanno separate: io rimango me, sola/o me e tu mantieni il sola/o tu. Riconoscendomi altro da te, rispetto, amo la tua alterità. Mantenendo la separazione tra me e te, riconosco i miei desideri, diritti, la mia autodeterminazione, autonomia e, così facendo, libero, promuovo i tuoi. Io mi separo, cioè mi distacco da te, mi distinguo. La fusione, l’indistinto, l’indiviso può durare per un periodo più o meno lungo (v. i 9 mesi di gestazione), ma se non si taglia il cordone ombelicale si muore, perciò tra madre e figlio avviene la separazione. Nel caso in cui non avvenga, la fusione può tramutarsi in un legame (devastante!) illusorio con l’altro/a, senza trasformarsi in separazione, la sola condizione che consente relazioni sane.
Paola: Separazione, distanza, distinzione, indivisione, sono infatti usati da Angela come sinonimi, Maria. Lo rilevo perché il termine separazione, pur non comparendo esplicitamente nei due enunciati di Putino, lo incontriamo tuttavia, diversamente formulato, in altri contesti: separazione nell’indiviso, congiungere nello spezzare – leggiamo – ed è un termine largamente utilizzato in psicanalisi per definire i presupposti indispensabili alla costruzione di una relazione non patologica.
Domanda: Ma qual è, secondo voi la particolare difficoltà che due donne incontrano nell’essere straniere senza distanze e vicine senza identificazioni?. Perché tra due donne è più difficile prendere coscienza di quella radicale e inevitabile separazione?
Cinzia: Penso che tutto nasca dal rapporto madre-figlia, da quella fusione simbiotica che lo contraddistingue. La relazione madre-figlia è la relazione più stretta che possa esistere. Sicuramente più stretta della relazione madre-figlio. Nel figlio la madre non si conosce e non si riconosce, è, e deve essere altro da sé, allo stesso modo il figlio non si deve riconoscere nella madre ma deve essere tutto ciò che il femminile della madre non è. Invece lo specchiarsi, il riconoscersi, l’identificarsi l’una con l’altra, è alla base della relazione madre-figlia: E’ da questo rapporto che nasce tutto. E’ già qui che non si riesce a trovare l’equilibrio: o come lei, o il suo opposto “mai come lei” per la figlia, o come me o contro di me per la madre. Non può esserci equilibrio. Ci sono donne che sono anche fisicamente uguali alle loro madri, che non hanno mai spezzato il cordone ombelicale. Ci sono donne che fanno del tutto per non essere come la loro madre, salvo poi trovarsi un giorno a guardarsi allo specchio e trovare Lei. E’ questo allontanarsi, distaccarsi, che non riesce mai del tutto, che è essere completamente straniere per non identificarsi, per non essere incorporate, ingoiate, distrutte. E’ questo voler prendere a tutti I costi le distanze, che secondo me è all’origine di quel senso di colpa che la maggior parte di noi porta dentro. Colpa per aver tentato di differenziarsi, di aver tentato di opporsi, di rifiutare l’identificazione, di aver posto fine alla simbiosi, di essere Io, Me. Ma questa operazione per riuscire ha bisogno di essere fatta in due, da Me ma anche da Lei, quella Lei che non lascerà mai andare. E se Lei non mi lascia andare, se Io sono ancora invischiata con Lei, come può essere possibile che con un’altra possa riuscire ad essere “ vicina senza identificazione”? Come può essere possibile che riesca a distinguermi senza paura di essere cancellata? E allora con un’altra proverò e riproverò e metterò sempre in atto la stessa relazione fino a quando?
Paola: Mi sembra molto importante, Cinzia, il tuo riferimento alla Colpa. La diversità, la divisione, la differenziazione e la distinzione vengono vissute immaginariamente come un tradimento e dì conseguenza come una colpa nei riguardi dell’altra/o ma c’è un tradimento e una colpa assai più grande ed è il tradimento di sé di cui parla Lonzi in queste poche righe:
Il misconoscimento mi appariva come estrema salvaguardia: abbandonare era niente rispetto al dolore di tradire me stessa.
Cinzia: Non so, Paola, ma è come se noi donne ci trovassimo spesso all’interno di un “doppio legame”, qualunque cosa fai, sbagli. Se resti nel legame con Lei, se non la tradisci per diventare quello che lei, non ti ha permesso di essere, tradisci te stessa; al contrario, se rompi IL legame, se ti permetti di essere te stessa, se ti distingui, questo tradimento, secondo me, viene vissuto con un senso di colpa più profondo. D’altronde per essere te stessa hai bisogno di distinguerti da Lei, per cui IL senso di colpa per aver tradito te stessa non può che essere secondario.
Paola: Hai fatto bene a ricordare il “doppio legame”, Cinzia perché, assieme al meccanismo di “identificazione proiettiva” di cui ci parla Klein, è un punto molto importante e, a mio parere decisamente sottovalutato su cui torneremo, mentre è invece indispensabile per capire e dar conto di ciò che può verificarsi in certi contesti.
Lorella: Riflettendo meglio sulla frase di Putino, ho compreso cosa mi aveva affascinato e allo stesso tempo turbato nel concetto che voleva esprimere. Credo che la dissonanza principale che mi ha suscitato si riferisca all’uso del termine “straniere”, che viene prima accostato con una sottrazione al termine “distanze” e poi al termine “vicine”. Mi sono chiesta come è possibile vivere l’estraneità nelle relazioni e sentire al contempo vicinanza e andando a guardare l’etimologia della parola “straniero” mi sono resa conto che questa dissonanza è solo apparente. La parola, infatti, deriva dalle preposizioni ex ed extra (come le parole strano e estraneo) che implicano qualcosa di “qualcosa all’esterno di me, fuori da me”, dunque distante da me perché non è in me. L’accezione con cui oggi utilizziamo la parola “straniero”, essendo profondamente legata alla stratificazione sociale creata sulla base della razza e della diversità culturale, ci rimanda a livello emotivo a qualcosa di molto più distante, di incomprensibile, di profondamente diverso da noi. Con questa precisazione, almeno a livello cognitivo, mi è più semplice comprendere il significato profondo dell’accostamento dei termini straniere senza distanze e vicine senza identificazioni, che coincide con la preservazione dell’alterità nella relazione: vivere e sentire l’altra persona come soggetto esterno e autonomo rispetto a me (cosa che, ad esempio, nella simbiosi madre-figlio dei primi anni di vita non si verifica) in modo tale che la diversità preservi questa giusta distanza e che la comunanza (di interessi, sentimenti, passioni, esperienze, ecc…) non diventi identificazione.
Leda: Prendere la forma di qualcun altro/a, dunque, ha una qualche relazione con quest’idillio simbiotico in cui ci si illude attraverso un salto logico di non essere radicalmente e inevitabilmente “straniere” l’una con l’altra? È una domanda che pongo a me stessa in relazione al mio intervento precedente per capire dove questa mia tendenza si colloca in rapporto all’idillio simbiotico. Non è una domanda a cui risponderò subito poiché forse la risposta l’ho già data, forse ancora non è mia completamente. Penso che la prima frase di Putino, definita da Paola come un “dover essere” espliciti prima di tutto una verità di fatto, ovvero l’impossibilità di essere l’altro/a, collocando tale finta possibilità ad un livello puramente immaginario. La simbiosi, quindi, è un modo per non far fronte alla coscienza della propria alterità, indica una resistenza o un’incapacità ad individuarsi come entità separata, come esistenza particolare con in sé il suo corso: un inizio, una via e una fine. La presa di coscienza della propria radicale separazione dal mondo e dagli altri implica il primo contatto con la propria finitudine. Ma la frase di Putino non constata semplicemente una realtà ma fornisce uno spunto per reperire la gioia che tale condizione, se accettata in tutta la sua tragicità, ci rileva. Straniere sì, quindi, inevitabilmente, ma senza distanze se questo inevitabile viene accettato in tutta la sua profondità, “vicine” a patto che non vi sia “identificazione” ovvero il cadere in quell’illusione di poter essere “due in Uno”, l’illusione allettante, sogno di pace e beatitudine che tanto ha attratto l’uomo (e la donna?) dando lui proprio quegli strumenti che inducono al salto logico a monte dell’illusione. Se il primato dell’Uno, detto anche primato del fallo, è quell’esistenza, a livello simbolico, di “due in Uno”, non è proprio in questa struttura che si manifesta la più tremenda cecità di fronte alla tragicità inevitabile della vita, la separazione? E separazione può vuol dire tante cose, separazione dal ventre materno prima di tutto, perdita di quello stato di completa unificazione tipica del bambino/a nelle sue prime fasi di vita, perdita del primo oggetto d’amore in termini psicanalitici, solitudine radicale e irriducibile spesso esperita attraverso il dolore in termini filosofici, tutto ciò non è che vita – in fondo.
Emanuela: Straniere senza distanze, vicine senza identificazioni. Più leggo questa frase di Putino e più mi colpisce nel suo significato, inteso come proposta di un approccio che prevede la mente aperta, ma soprattutto significa spogliarsi di quei meccanismi di difesa dell’io per favorire l’intesa in un contesto nel quale si opera insieme. Cogliere la differenza rinunciando all’identificazione rassicurante, mettersi nei panni altrui senza identificarsi o dovendo rinunciare ai propri. Il fascino di questa frase per me consiste nel saper rinunciare al bisogno di affermare la propria identità e accettare il rischio di perdersi e doversi poi ritrovare, scoprendomi o riconoscendomi apertaMente straniera, distinta dalle altre in gruppo e sola, ma senza più confini.
Rossana: Riprendendo il filo teso da Cinzia e Leda sul rapporto madre-figlia, di fatto la donna è il primo oggetto d’amore. E di odio. Klein considera l’odio originario quanto l’amore, Freud lo ritiene addirittura precedente all’amore, considerandolo funzionale alla separazione, in quanto è la reazione dell’infante alla frustrazione, quando si rende conto che il mondo-madre non è tutto soddisfazione-sé (narcisismo) e comincia a concepire l’esistenza dell’oggetto altro-da-sé, esterno, incontrollabile e perciò fonte di angoscia. Se nella simbiosi avviene una relazione nella quale entrambe sono necessarie per la sopravvivenza dell’altra, con l’idealizzazione reciproca, sottrarsi richiede un atto di aggressività che implica la colpa di un triplice delitto. La prima è quella derivante dalla delusione per il frantumarsi dell’immagine idealizzata dell’altra, la sua svalutazione, con il rifiuto conseguente; la seconda è perché si immagina che sottraendosi dalla simbiosi l’altra perirà. La terza è perché, sapendo che ciò non accadrà, l’illusione di importanza che ci attribuiamo crolla e con l’immagine idealizzata di noi, lasciandoci nude senza sapere chi siamo avendo rotto lo specchio. Perciò si trascina quel gioco di proiezioni, che evita la separazione per paura della rottura. Da qui la colpa che insidia il rapporto tra donne: ti amo se sei come me, ti odio se siamo diverse. Come dice Paola, l’odio tiene legate per evitare l’odio e avere l’amore. Ma questo è un amore che fa di me oggetto, non soggetto. Questo problema sembrerebbe non porsi per il maschio che è già diverso dalla donna-madre e non deve diventarlo, da capire se davvero dalla madre si separa oppure no.
Cinzia: Mi è capitato di essere pugnalata alle spalle proprio da quelle donne che avevano idealizzato la relazione con me.
Emanuela: Mentre sono curiosa e attratta da straniere che potrei sentire vicine, entro in contrasto con le vicine che sento invadenti coi loro saperi pesanti, giudicanti, inflitti in contesti dove i saperi potrebbero invece confluire in una dimensione di crescita non solo personale ma propriamente collettiva. Crescita come consapevolezza dei propri limiti e delle proprie risorse e in contrasto con ogni forma di negazione rappresentata dalla distanza che poniamo da ciò che siamo o crediamo di essere, verso ciò che è considerato estraneo, straniero a ciò che siamo o crediamo di essere. Perché crediamo? Perché nel momento in cui poniamo le distanze dalla straniera, significa che sentiamo minacciata la nostra identità, personalità, l’appartenenza a un gruppo. Porre la distanza per non dare spazio a possibili cambiamenti in noi stesse.
Paola: Mi pare che le parole di Putino abbiano avuto l’effetto di un rompicapo….e il fatto che diano da pensare è già un risultato apprezzabile.
Domanda: Secondo voi l’indicazione contenuta nel primo enunciato: Dovremmo saper essere straniere tra noi senza distanze e vicine senza identificazioni, vale limitatamente al preciso contesto femminista cui Angela fa riferimento o è un’indicazione di carattere universale che include dunque, oltre alle relazioni fra donne, le relazioni fra uomini e le relazioni fra uomini e donne? E se così fosse, ciò non andrebbe a scapito della possibilità di scelta, della possibilità di adottare nelle relazioni un criterio selettivo?
Paola: Le parole di Angela si riferiscono senz’altro ad un contesto molto preciso ma ritengo che la sua indicazione sia valida, in generale, per ogni tipo di relazione il che non significa stabilire un principio di obbligatorietà nelle relazioni che possono esigere, in alcuni casi, l’applicazione di un criterio selettivo.
Domanda: Il femminismo della differenza si è reso conto, secondo voi, dei rischi legati al mito della sorellanza e dell’indivisione, a quel particolare genere di vicinanza che – diversamente da quella vicinanza senza identificazioni teorizzata e praticata da Putino – può potenziare lo scatenamento di processi identificatori che, vissuti e “maneggiati” senza la necessaria competenza, rischiano di produrre effetti devastanti.
Rossana: Queste due questioni mi portano su piani distinti allo stesso tema, quello della dimensione gruppale, che riguarda sia donne che uomini, sebbene, credo, in modo differente. Ho l’impressione che nell’ esperienza femminista, in generale, non si sia abbastanza tenuto delle dinamiche potentissime provocate dai gruppi e che le donne che facevano autocoscienza con questo dispositivo non siano state in grado di gestirlo con la sufficiente competenza. Il gruppo, infatti, tende a far “regredire” le persone che ne fanno parte e senza accorgersene cominciano a funzionare attivando meccanismi arcaici – scissione, idealizzazione-svalutazione, identificazione proiettiva. Bion spiega bene come i gruppi producano degli “assunti di base” ossia dei presupposti inconsci ed emozionali, che vanno in direzione diversa da quella consapevole. Si potrebbe ipotizzare che i gruppi femministi inizialmente si costituissero sull’assunto “attacco-fuga” rispetto al maschile, compattandosi “contro” di esso e valorizzando la propria identità femminile nell’emancipazione. Al tempo stesso le donne, con il desiderio di uscire tutte insieme dalla dipendenza dal maschile, l’hanno spostata sul gruppo, posizionandosi in assunto di dipendenza e identificandosi tutte con l’ideale gruppale di liberazione dal potere patriarcale. In ogni caso, il maschile aleggiava comunque, come fondamento rimosso di una equivalente dipendenza. Dopo la prima fase di idealizzazione nella quale l’indistinto, appunto, prevale, uscendo da quello nel processo di inevitabile differenziazione, immagino si possano essere attivati i meccanismi di identificazione proiettiva di cui è stato detto: il cerchio delle donne, smettendo di confermare l’un l’altra l’ideale di sé, diventava persecutorio: i volti potevano essere percepiti come “frammenti di specchio” rinvianti un’immagine a sua volta frammentata, moltiplicando le proiezioni reciproche, le conflittualità e probabilmente le competizioni, facendo andare a pezzi le persone, incapaci di riflettere ancora su di sé. Di conseguenza, l’assunto “‘accoppiamento”, cioè l’attesa di un(a) “messia”, creativa e geniale, che rompesse con il potere costituito, ponendosi a guida del gruppo verso la salvezza, potrebbe aver preso il sopravvento: ecco allora che le donne “carismatiche” assumevano il ruolo di conduttrici senza esserlo, anzi essendo esse stesse dentro le dinamiche immancabilmente transferali e controtransferali, assorbendo la confusione con la riattivazione dell’assunto di dipendenza, l’unica àncora alla quale aggrapparsi nel momento in cui le emozioni non erano più contenute. Da un lato, quindi, una via d’uscita può essere stata quella ancora gruppale, dove “‘il personale è collettivo” è finito nella pratica del fare e, poi, nell’ordine simbolico della Madre, abdicando la propria identità a quella collettiva, seppur ‘femminile’ (?). Dall’altro, una via d’uscita alternativa potrebbe essere stata quella di ritrovare un “fuori”, un luogo terzo, spesso psicanalitico, per guardare con distanza tutto questo, per “ritornare in sé” e forse trarre un sospiro di sollievo avendo un oggetto di dipendenza tutto per sé, l’analista, il Padre. Questa distanza è stata purtroppo fatale, perché non ha più riportato alla vicinanza tra donne separate e con una propria identità, ma si è fermata lì, sulla soglia tra la diffidenza reciproca e l’attesa nostalgica.
Leda: No, il femminismo della differenza non si è ancora reso conto del potenziale distruttivo insito in relazioni tra donne fra cui non è avvenuta quella separazione a cui ci esorta Putino. Come sappiamo, il femminismo ha messo in luce l’importanza della vita privata e i suoi profondi risvolti in ambito politico, per questo, le relazioni in generale e le relazioni tra donne in particolare, sono state messe al centro di un dibattito che continua ancor oggi e verte sul tema principale dei ruoli in connessione con la libertà ad essere ciò che si è (una libertà definita nella differenza sessuale). Ma proporre una riflessione di questo tipo, implica l’essere disposte a guardare innanzitutto le proprie vite e le proprie relazioni facendo riferimento al rapporto primario madre-figlia che ha un’importanza fondamentale nel modo di rapportarsi di una donna con le esponenti del proprio sesso. Per questo ci siamo dedicate al lavoro collettivo Madri e non madri da poco uscito, per capire come ciascuna di noi si colloca in relazione a quest’esperienza sia dal punto di vista di madre che di figlia. Quest’operazione ha valenza politica in un senso profondo che solo la psicanalisi, in quanto sapere dell’inconscio, ha portato a galla. Il femminismo, quindi, per le domande che ha posto alle donne, che le donne hanno posto a se stesse – forse ad indicare, come ci dice Paola, una maggior capacità e tendenza delle donne a guardarsi – portin superficie un sapere necessariamente inconscio ponendosi in linea, ma non in coincidenza – e come potrebbe visto che la psicanalisi è stata fondata dai padri? – con l’inconscio. Grazie all’approfondita ricerca di Paola che ha tracciato le tappe del passaggio dai gruppi di autocoscienza a quelli dell’inconscio e infine alla pratica del faresiamo riuscite a cogliere l’esistenza di un nodo irrisolto nel femminismo, un nodo le cui conseguenze si intravedono da un lato in atteggiamenti di rifiuto verso temi quali la maternità, il rapporto madre-figlia (questa incapacità alla separazione a cui ci esorta così profondamente Putino è sintomo di un irrisolto), dall’altro a forme di teorizzazione straordinarie nella loro potenza che si basano proprio su un rapporto madre-figlia staccato apparentemente dalle esperienze vissute e reso modello da seguire. Ci chiediamo se un modello da seguire possa veramente aiutarci nelle nostre relazioni tra donne e possa evitarci un’analisi approfondita di noi stesse in relazione alla nostra esperienza. Ci chiediamo a cosa porti questa teorizzazione che sembra occultare l’esperienza invece che portarla a galla a giudicare da molte testimonianze (Cfr. Nel Nome della Madre, della Figlia e della Spirita santa) di situazioni deliranti presenti nei gruppi di Autocoscienza che si tenevano negli anni ’70-’80 in cui proiezioni identificatorie emergevano spaventosamente ed erano difficilmente gestibili. Noi vogliamo ripartire da capo e guardare le nostre esperienze prima di teorizzare – consapevoli di avere qualche strumento in più rispetto alle donne degli anni ’70, se non altro perché abbiamo letto e continuiamo a leggere ciò che ci hanno lasciato – vogliamo capire, poi, se le teorie che sono state proposte finora possono esserci congeniali oppure no.
Paola: Secondo me sì, le femministe, almeno alcune, se ne sono talmente rese conto da abbandonare l’autocoscienza e la pratica dell’inconscio e, con esse, quella pericolosa e spesso devastante vicinanza non senza identificazioni che da quelle pratiche – e come risulta da alcune testimonianze – venivano attivate e incrementate. Si verificavano e prendevano corpo, nelle relazioni fra donne, dei processi identificatori ad altissimo rischio. Non esclusi quelli caratterizzati dalla presenza di quel tipo di identificazione teorizzata da Klein, “l’identificazione proiettiva”, che molti studiosi esperti hanno addirittura paragonato a un fenomeno di possessione che può sorgere all’interno di un rapporto interpersonale più o meno stretto. Si tratterebbe di una riedizione del concetto junghiano di “infezione psichica”, o di un fenomeno paragonabile alla folie à deux. Credo che il passaggio alla “pratica del fare” e l’istituzione di un Ordine simbolico della madre siano stati un tentativo, sia pure maldestro, di uscire da un’impasse dovuta alla mancanza delle necessarie competenze per arginare “quel fiume di parole” di cui parla Lonzi, e a una certa improvvisazione nel gestire lo scatenamento di fenomeni psichici sintomatici che avendo a che fare con l’inconscio erano estremamente delicati da maneggiare.
Domanda: Della psicanalisi, nel bene e nel male, il Femminismo ha fatto abbondantemente uso. In che misura l’opera di Melanie Klein e, in particolare, il suo importante contributo sulle identificazioni proiettive sono state oggetto di serio approfondimento da parte del femminismo italiano?
Paola: Credo che la messa in discussione kleiniana del valore simbolico della paternità e l’idea di un ruolo paterno assimilato a quello di una buona madre, l’idea, insomma, di un padre “mammo”, abbia riscosso in alcuni ambiti del femminismo, soprattutto inglese, un certo successo. Per altre femministe Klein ha rappresentato un’alternativa al machismo e a fallocentrismo freudiano e lacaniano. Ma poiché abbiamo toccato un punto importante, la nota dolente che riguarda i processi di identificazione, mi sembra opportuno precisare che cosa intenda Klein per identificazioni proiettive. L’identificazione proiettiva, detto in estrema sintesi, non è altro che la proiezione delle parti di sé in un’altra (l’oggetto) di cui si vuole prendere possesso, di cui ci si vuole appropriare. “L’oggetto” – scrive Klein – viene “percepito come dotato delle caratteristiche della parte di sé proiettata in esso”. Lo scopo dell’identificazione proiettiva è quello di sbarazzarsi della parte indesiderabile di sé – una parte minacciosa in quanto disintegrata dalla pulsione di morte – attraverso un’inversione delle identità che porta alla distruzione dell’altra. Ma è anche possibile che l’identificazione proiettiva mandi nell’altra, affinché le conservi, le parti buone di sé e, in questo secondo caso, essa sfocia in una idealizzazione dell’altra/a che però – se è eccessiva – finisce per produrre – ed è questo il punto pericoloso e delicato – una svalutazione di sé. Ma c’è di più, c’è che in entrambe i casi, attraverso queste manovre proiettive, ne va dell’identità e delle specifiche qualità di chi le compie dal momento che questa identità può essere assicurata “solo a spese di un puntellamento sull’altro” (Cfr. Kristeva, M. Klein, la madre, la follia)
Domanda: Restando in tema di identificazioni e considerato il fatto che questo termine introdotto da Putino nel primo enunciato è da lei posto in tutta la sua problematicità e pericolosità, è lecito chiedersi: Chi è colui o colei che proietta? E quali sono le ragioni che inducono una persona a servirsi, nelle sue relazioni, di questo insidioso meccanismo?
Paola: C’è da dire, innanzi tutto, che la proiezione è, in una certa misura, un meccanismo piuttosto comune. La differenza fra proiezione e identificazione proiettiva – così come quella fra salute e malattia – non è qualitativa ma quantitativa nel senso che quest’ultima contiene in misura maggiore il carattere della violenza, dell’ intrusione, della coazione. E tuttavia neppure le identificazioni proiettive sono di per sé sempre patogene, e a seconda, appunto, della qualità, possono essere “benigne”. Del resto l’humus in cui cresce e matura l’io del bambino non è altro che il risultato di una serie di identificazioni. Chiunque può perciò mettere in atto questo meccanismo e lo fa, sostanzialmente, per due ragioni fondamentali già evidenziate da Klein allorché nel 1946 costruì su questo concetto una teoria. Come già detto, ma vale la pena ribadirlo, chi ha bisogno di proiettare una parte di sé fuori di sé, lo fa perché teme che questa parte “cattiva”, restando all’interno, possa distruggere le parti “buone” del sé, oppure per il motivo opposto: proteggere la parte buona di sé proiettandola all’esterno per ripararla e dagli attacchi della parte interne “cattive”. Se parliamo di parti buone e di parti cattive come di due parti opposte è perché, effettivamente, siamo di fronte, in alcuni casi, a una vera e propria scissione che fa sì che queste due parti siano incapaci di integrarsi (Kernberg) e il problema sta proprio in questa mancata integrazione. La scissione è un potente meccanismo di difesa che porta un soggetto a buttare fuori di sé e a rinnegare le parti cattive al fine di evitare quello che sarebbe per lui/ lei, un conflitto così lacerante da essere insostenibile. Si tenta, così, attraverso la scissione, di conservare un certo equilibrio psichico a scapito però dell’esame di realtà che, subendo consistenti menomazioni, finisce per risultare compromesso.
Rossana: Innanzitutto separarsi è un processo, ossia non si parte già separate. Questo vale sia internamente sia esternamente. Credo che ciò che Putino propone sia l’esito di un percorso, che oscilla continuamente tra l’angoscia perturbante di non sapere dell’altra, quindi la necessità di identificarla con qualcosa di conosciuto, me stessa, per poi tollerare che tale illusione si infranga, sopportando la perdita, la depressione, l’insicurezza e procedendo insieme, apprendendo alla fine qualcosa di più di entrambe nella realtà della nostra relazione. Temo sia inevitabile che passando tra illusioni e delusioni, i sentimenti oscillino tra l’amore e l’odio, e se siamo capaci di contenerli senza espellerli, tollerando l’ambivalenza, riusciremo a mettere insieme i pezzi, i nostri, lasciando all’altra i suoi. Il rapporto soggetto-oggetto deve diventare rapporto soggetto-soggetto.
Domanda: Sempre a questo proposito, mi domando e vi domando: Ma che identità è un’identità che si fonda e può sussistere “solo“, come scrive Kristeva, “a spese di un puntellamento sull’altro?”
Paola: Questa è una domanda importantissima che tocca la questione del rapporto fra il soggetto e l’altro – l’altro inteso come simile, l’Altro inteso come ordine simbolico. Nessuna di noi esiste come soggetto autarchico, autonomo, autosufficiente e totalmente indipendente dall’Altro e dai/dalle nostri/e simili, la precarietà – lo ricordano Butler e Cavarero e prima ancora Arendt – è la nostra condizione umana. La stessa “identità” è, per certi aspetti, un concetto problematico che non possiamo qui approfondire come si dovrebbe ma resta il fatto che un’esistenza vissuta – come dice Kristeva – “a spese” di qualcuno/a, a spese di un puntellamento sull’altra/o, indica una fragilità identitaria accompagnata da una difficoltà a definire i confini fra sé e l’altro/a. Il “puntellamento” è, insomma, la “stampella” che l’altro/a necessariamente diventa per qualcuno/a. Va da sé che nessuno/a può funzionare da stampella per un’altra/o, senza farne, presto o tardi, “le spese” che possono essere, in molti casi, pesantissime. Ritornando alla frase di Putino, possiamo dire, senza timore di sbagliare, che la vicinanza assicurata dalla stampella è il contrario della vicinanza senza identificazioni. Sempre a proposito di stampelle e con particolare riferimento all’identificazione isterica, non è un caso che Putino in Amiche mie isteriche utilizzi concetti come “prossimità” e “medesimezza” su cui l’isteria fonderebbe la propria sicurezza, nonostante non faccia che esibire ossessivamente “la propria differenza” nella misura in cui questa differenza non c’è. Le sue modalità di relazione – duali – sono il solo strumento di cui dispone per misurare l’identità femminile e rappresentano una difesa dai pericoli di cambiamento.
…A proposito di stampelle..
Leda: È strano e non lo è allo stesso tempo, che a distanza di un po’ di tempo dalla stesura del testo relativo alla maternità, si siano aperte in me delle ferite antiche che ho tentato di ricucire molte volte nella mia vita ma mai con pieno successo.. Sembra quasi che il dolore non sia mai finito e non possa mai finire veramente, qualche toppa qua e là non nasconde la ferita, e questa è sempre pronta a sanguinare alla prima occasione. Anche quest’ultimo lavoro, appena pubblicato, mi ha dato modo di ritornare nuovamente sul rapporto tra me e mia madre per capire, questa volta, il gioco identificatorio con lei, un gioco che mi pone non poche domande ma che posso riassumere – e lo faccio con voi perché voi siete state mie compagne di pensieri – in questo modo: io sono stata per lei ciò che le ha permesso di esistere (almeno nella mia immaginazione), perfetta come lei non aveva mai potuto essere, sono stata la sua stampella per rimettersi in cammino, madre di mia madre e, al tempo stesso, forte come un maschietto, fino al momento in cui lei non ne ebbe più bisogno.. L’identificazione si è giocata sul piano dell’essere per l’altra la parte mancante, per arrivare, alla fine del gioco, ad essere io stessa mancante nel momento in cui sono stata privata del mio ruolo di stampella perché non più necessario. D’altronde, una forma che sa solo plasmarsi sulle altre non ne ha una propria. Dunque, diventai parte mancante che cerca una stampella, una forma, questa volta non per sostenere ma per essere sostenuta facendo a schiaffi con il mio ruolo precedente, ovvero quello del bastone, con cui continuavo a identificarmi erroneamente, perché questa volta ero io ad averne bisogno. In questi due ruoli in confusione dentro di me: la parte negativa di chi non ha ciò di cui ha bisogno e nasconde gli spasmi di sofferenza perché prova vergogna di fronte ad un vuoto di senso, se non di amore, enorme e la parte positiva di chi sa, in fondo, di saper amare e sa che vorrebbe farlo ancora come una volta facendo a meno di sé perché, in fondo, la necessità ci porta di fronte a situazioni in cui il dolore dell’altro/a sembra più forte del tuo, più insostenibile. Anche quando me ne andai, soprattutto quando me ne andai lontana da tutto, rimisi in atto in una miscela esplosiva e fortemente autodistruttiva questo gioco di ruoli, a riprova che la lontananza fisica non indica necessariamente una separazione. Ritornai sempre lì a dirmi di non aver bisogno, a non chiedere e a cercare di essere una stampella per l’altro/a. La verità è: ciò che disprezzo di me stessa e ciò che ho disprezzato anche di mia madre, è l’impossibilità ad esistere senza l’altro/a e che più l’ho disprezzata, cercando di rispondere all’ideale opposto, più cresceva in me la necessità dell’altro/a. Ma ancora di più, forse, ciò che mi ha spinta a scappare era quel senso di vuoto e mancanza che attribuendomi come una colpa, allo stesso tempo rifiutavo. Una colpa, infatti, è pur qualcosa da portare, mentre una mancanza è qualcosa che ti spoglia e ti lascia indifesa di fronte alla vita e di fronte al mondo intero. Ricordo spesso, in questi giorni, alcuni momenti di disperazione profondissima a cui un mio rapporto di qualche anno fa mi ha spesso portata, lo ricordo con tristezza ma anche, stranamente, con una sensazione di immensa libertà e forza. E proprio in quei giorni, infatti, dove tutto ciò che avevo cercato di costruire, o forse, a questo punto, di distruggere, mi scivolava via dalle mani e mi portava di fronte, con costanza, a quella radicale solitudine in cui alzi gli occhi al cielo non sentendo più il tuo corpo e ti accorgi di esserti eretta una prigione intorno quasi come un gioco che poteva portarti alla morte, come alla rinascita. La distruzione, in quel frangente, mi portava in fondo, fino a scoprire l’assurdità dell’esistenza e mi regalava il segreto più prezioso dell’universo, ovvero la consapevolezza di essere artefici di se stessi. Credo di essermi sempre scelta, in fondo, il mio dolore cercando qualcosa che mi dicesse dov’ero ed ora, quando mia madre ancora una volta mi chiede ciò che mi ha chiesto per tutta la vita, ovvero di essere madre di mia madre, riesco pian piano a sorridere di fronte alla voragine che la sua espressione disperata mi apre nel petto, forse ora sono veramente capace di fare ciò che desidero senza perdermi ancora.
Rossana: Noi veniamo al mondo gettati dentro continue interazioni con gli altri. Cos’è quindi l’”identità” – sia essa forma assunta dall’Io, sia consapevolezza di Sé – se non il frutto di continue identificazioni? Attenzione: se “l’Io è un Altro” nel senso che l’altro mi determina, siamo nella mimesi che ha bisogno dell’altro come “stampella” su cui, appunto, appoggio lo specchio della mia identità. Se, invece, l’intendo nel senso che mi posso far attraversare dall’altra, posso identificarmi nella misura in cui quello che è e possiede mi “risuona” dentro, ossia fa echeggiare in me cose che già posseggo, mi consente di divenire ciò che sono e non so ancora di essere. Insomma, nella vicinanza non prendo da te, ma attraverso di te trovo in me ciò che mi è sconosciuto e che in te ri-conosco. Senza radicamenti né domini.
Paola: C’è un importante passaggio di Adriana Cavarero in cui, dialogando con Butler, smitizza il mito dell’’autonomia e dell’indipendenza totale del soggetto indicando uno scenario interessante che – non diversamente da quello descritto da Putino – contempla un tipo di “dipendenza” intesa come vicinanza senza identificazioni. Vale la pena leggerlo:
“Non ritengo che la relazione di dipendenza sfoci necessariamente in un’ansia di indistinzione che è coestensiva alla vita. Vedo piuttosto il pericolo che il sogno vecchio e moderno, dell’autonomia del sé, scambi la relazione per indistinzione e la dipendenza per incorporazione. Detto altrimenti, le patologie egocentriche del soggetto moderno o, se vuoi, dell’ontologia individualista, mi preoccupano molto di più delle sue ansie – alquanto coerenti – nei confronti dell’altro in quanto luogo di contaminazione, disfacimento, dissoluzione. Perché dal punto di vista della storia della filosofia occidentale, se ci pensi bene, c’è appunto una certa logica nella follia di questo “soggetto” che, dopo secoli spesi a celebrare la sua autonomia e autopoiesi, non appena scopre la dipendenza, viene colto dal timore di sparire nell’altro” (A. Cavarero, Differenza e relazione)
Domanda: Ancora a proposito dell’identificazione proiettiva, esiste una particolare situazione che si può venire a creare all’interno di una relazione e che viene indicata e descritta come “pressione interpersonale”. Che cosa si intende con questa espressione? E come viene esercitata questa pressione in una relazione? E’ possibile assimilarla a una forma di manipolazione?
Paola: La pressione interpersonale è una specie di forza che agisce in particolari condizioni, nel caso in cui esista, per esempio, fra due persone, un forte legame interpersonale, un legame intimo o di dipendenza qual è, per esempio, il legame madre-bambino, analizzante-analista, paziente-terapeuta. Mi viene in mente, a questo proposito, un altro concetto teorico, quello di doppio legame per stabilire il quale sono necessari scambi comunicativi caratterizzati da una certa importanza, continuità temporale e assiduità. In altre parole, un’identificazione proiettiva non si sviluppa senza le condizioni preliminari sommariamente descritte. Per dare l’idea di quale sia la funzione di questa “pressione” esercitata da qualcuna/o nei riguardi di un’altra/o, Melanie Klein utilizza la parola “controllo”. La pressione sarebbe dunque, per lei, una forma di controllo esercitato da parte di chi proietta su colui/colei che riceve la proiezione e sarebbe finalizzata a verificare, da parte del/della controllante, che un certo sentimento – buono o cattivo – si sia davvero depositato nell’altra/o. Se il controllo sia o non sia una forma di manipolazione sarebbe da discutere.
Domanda: A questo punto, dopo il quadro delineato, è giocoforza tornare sulla precedente domanda per capire se davvero le donne che facevano parte del movimento femminista negli anni ’70, abbiano avuto una chiara percezione del rischio che correvano e attraverso quali strumenti abbiano cercato di contrastare il pericolo di “infezione psichica” e di folie a deux. L’abbandono dell’autocoscienza e della pratica dell’inconscio e il passaggio successivo alla” pratica del fare” potrebbero dunque essere considerate, come mi pare abbiate ipotizzato, un tentativo di porre rimedio a questo rischio?
Paola: Dire, come in precedenza rilevato, che di questo rischio ci fu, ad un certo punto, una chiara percezione e l’abbandono dell’autocoscienza prima e della pratica dell’inconscio e il passaggio alla pratica del fare, ne sono la concreta testimonianza. Ci sono le parole di tante donne, storicamente documentate, che ci raccontano e ci trasmettono il lor grado di disagio e il tipo di sofferenza vissuta all’interno dei gruppi di autocoscienza fino in qualche caso, al suicidio, Ne ricordo solo alcune:
Quando si parla di inconscio, quando ciò che è rimosso ricompare, nel gruppo si scatenano reazioni, dinamiche difficili da gestire, scattano meccanismi di attesa. Non c’era, nei nostri gruppi, quella capacità di distacco, quel controllo che in una pratica terapeuta spetta all’analista. (L. Melandri, Una visceralità indicibile)
La pratica dell’inconscio voleva dire entrare in una specie di seconda natura (…) era come “affondare in un imbuto da cui non sai se riuscirai a risalire. (Ibid.)
Lo stare tra donne sviluppa angoscia, perché manca qualcosa tra donne, manca l’uomo, manca il fallo; l’angoscia di castrazione diventa sempre più forte; se in più c’è incapacità di elaborarla collettivamente, allora si moltiplicano le domande di analisi e andiamo ad arricchire gli psicanalisti. (Ibid.)
Il mio percorso è stato diverso. Arriverei addirittura a dire che senza un’analisi individuale, durata moltissimo tempo e iniziata nel 1984, dopo essere andata via dalla Libreria delle donne e aver lasciato il gruppo n. 4 la mia vita sarebbe stata segnata solo negativamente da quella specie di pietrificazione che ha preso a un certo punto il movimento delle donne (…). Alla fine quando ho visto che tutto veniva azzerato, che nessuna delle difficoltà dei rapporti fra donne veniva presa in considerazione come oggetto di analisi, quando il cambiamento non era più all’ordine del giorno sia a livello personale sia a livello politico generale, allora sono andata via dalla Libreria – e non in modo indolore – e sono andata in analisi, con una posizione di totale rifiuto, con un senso di morte per tutto ciò che prima, per me era stato vita. Sono stati nove anni in cui non ho voluto sapere più niente del femminismo, anche se alla fine sono riuscita a recuperarne gli aspetti positivi. (Ibid.)
Domanda: Come mai di questi aspetti, di questi difficili momenti legati a certe pratiche – autocoscienza e pratica dell’inconscio – oggi non si parla? Si rimuove? Si censura? E’ forse per questo che dell’autocoscienza oggi si pronuncia e si legge solo la parola come se nulla di quanto sperimentato e raccontato fosse accaduto?
Leda: Si, è proprio in seguito alla presa di coscienza che la pratica dell’autocoscienza è una pratica oggi solo nominata e non realmente attuata che abbiamo deciso di proporre un laboratorio a Paestum 2013 in cui ripartire da dove questa pratica era stata interrotta per capire innanzitutto perché era stata così improvvisamente abbandonata. Quali rischi si celano dietro a questa pratica? Abbiamo avuto modo, nella nostra esperienza, di tastare con mano situazioni molto simili a quelle che Carla Lonzi descrive nel suo Diario, situazioni di intensa confusione in cui elementi di ognuna si proiettavano nel gruppo dando adito a situazioni difficilmente sostenibili. Ci siamo salvate grazie all’autenticità che ha permesso a ciascuna di noi di riconoscere i suoi punti dolenti e li ha, grazie a questo, elaborati nel gruppo, per me, almeno, è stato ed è cosi. Abbiamo anche subito delle perdite che ci hanno ferito pur in modo diverso. La nostra apertura ha, quindi, una condizione, ovvero la capacità di vedersi e di riconoscersi nella propria positività e, cosa più difficile, anche nella propria negatività. Ma questo ci è risultato possibile fino ad oggi grazie alla commistione della nostra ricerca con i versanti della psicanalisi e della filosofia che appaiono inscindibili dal femminismo. Questa commistione di saperi non ha trovato un suo equilibrio durante l’esperienza dell’autocoscienza negli anni ’70 anche se era certamente latente l’inscindibile relazione tra psicanalisi e femminismo – come ci dimostra il Diario di Lonzi e Amiche mie Isteriche di Angela Putino. La pratica del fare ha oscurato questo periodo di estrema fertilità di pensiero ma anche di raggiungimento di un’ impasse dovuta alle situazioni di estrema confusione – di delirio – che hanno reso l’esperienza dell’autocoscienza insostenibile. Noi cerchiamo di coniugare alla luce di un’analisi dell’esperienza delle donne che ci hanno preceduto e in base alla nostra esperienza in corso, un altro modo di sostenere l’insostenibile.
Domanda: Che funzione ha avuto, nel processo imprevisto di involuzione sintomatica avvenuta all’interno del femminismo, la creazione, da parte di alcune femministe, di un ordine simbolico della Madre?
Paola: Ha avuto, a mio parere, la funzione che le ho assegnato nel mio libro: il tentativo illusoriamente “terapeutico” di riparare al disordine creatosi all’interno del femminismo attraverso l’invenzione di un nuovo ordine: l’Ordine simbolico materno istituito come “terapia politica” dell’isteria. I frutti di questa “terapia politica dell’isteria” – che bisognerebbe peraltro definire che cosa sia – sono sotto i nostri occhi e, considerati gli attuali esiti emancipazionisti, c’è da dubitare che questa “cura” abbia avuto l’effetto desiderato. “Fare l’uomo” è, infatti, ciò in cui passione e sintomo isterico coincidono.
Domanda: In sostanza e andando al cuore della questione posta dai due enunciati da cui questa Conversazione ha preso avvio, l’ Ordine materno teorizzato da Muraro ha realizzato l’obiettivo putiniano di una vicinanza senza identificazioni e di una estraneità senza distanze o ha preso la forma di quello che Putino ha definito nel suo libro “un filo unificante e dispotico”, una “via regia” che vale come “campione” e come paradigma di esercizio di un dominio?
Paola: Direi proprio di no, ma che a dirlo sia io non è importante e credo conti poco. La sola cosa che davvero conta e di cui bisogna essere informate, è ciò che Putino ha scritto di suo pugno in merito all’istituzione di tale ordine materno in Amiche mie isteriche in risposta a La posizione isterica e la necessità della mediazione di Muraro. E’ evidente che se il percorso indicato da Angela e contenuto, in sintesi, nella frase riportata all’inizio fosse stato interiorizzato e praticato dalle donne con cui era venuta in contatto nel senso da lei inteso e teorizzato, Amiche mie isteriche non avrebbe avuto ragione di essere scritto. E invece leggiamo:
Negli anni ’90, una parte del femminismo italiano tenta di dare una svolta alla libertà femminile: se attraverso l’amore della madre ogni donna dà valore a se stessa occorre individuare una serie di pratiche di relazioni tra donne che, direttamente o indirettamente, si connettano a tale consapevolezza. Molti elementi che erano stati messi in campo da una rivoluzione femminista più eterogenea vengono attirati in questa orbita, con il rischio di venir composti e anche fissati nello schema relazionale materno. Tuttavia, non precisamente di amore materno si tratta (…) ma dell’”attaccamento isterico alla madre”. E’ da chiedersi inoltre se questo legame faccia approdare a un simbolico e se realmente l’elaborazione simbolica sia la posta in gioco (…). Va subito fatto emergere il clima che tale ricorso isterico al materno ha suscitato. Molte espressioni, contenuti, analisi dello stato delle cose e dei rapporti si sono snodati intorno a questo nucleo che metteva al centro l’isteria. Esso ha liberato procedimenti e corretto posizioni; ha articolato punti cruciali. Ma è stato semplicemente un donar senso a un materiale precedentemente opaco, o è stato il senso che ha prodotto una diramazione di effetti e di significati resi possibili solo grazie e un filo unificante ma anche dispotico? (A. Putino, Amiche mie isteriche)
Rossana: Considero che le donne “della differenza” con la costituzione dell’ordine simbolico della madre abbiano compiuto un atto di riparazione rispetto all’odio, pur riconosciuto a parole, per la madre, sostituendolo con l’amore materno assoluto e reciproco, scambiato con altre donne, nel tentativo di ri-avere ciò che è mancato nel rapporto con l’origine, quasi nell’ordine di una coazione a ripetere. Cioè: invece che fare il lutto di un amore necessariamente inappagante, della perdita della madre idealizzata, aprendo alla possibilità di una relazione con la madre reale, ossia la donna che lei è, hanno impostato un dispositivo che regredisce ripristinando un’unità simbiotica chiamandola simbolica. Naturalmente l’odio rimosso non scompare, ma lavora “sotto le fondamenta” creando legami indissolubili e costringendo all’omo-sessualità normativa. La “pratica dell’affidamento” e la “disparità”, portate come valorizzazione della genealogia femminile, si dimostrano in realtà vincoli di dominio-sottomissione che stabilizzano ed evitano la separazione e la differenza stessa. Chiara Zamboni in un’intervista dice testualmente:
…perché quando io stimo molto una donna più giovane di me, o anche quando stimo una donna più grande di me, le considero identiche a me, non che ci rassomigliamo, identiche a me. Questo è proprio il continuum materno. […]. I disastri sono poi arrivati nel momento in cui le altre non stavano a questo gioco di cui si rendevano conto, per cui dalle altre io pretendevo esattamente le stesse cose che pretendevo da me e pensavo che loro pensassero le stesse cose che pensavo io. (Zamboni, Perché non abbiamo avuto figli, P. Leonardi, F. Vigliani)
Domanda: Che cos’è, che cosa intende Angela Putino per funzione guerriera?
Paola: La funzione guerriera, di cui Angela ci parla, è altro da ciò che banalmente si pensa con il rischio di ingenerare equivoci. E’ innanzi tutto una funzione separativa, è quella funzione che recide, spezza quel ”filo dispotico e unificante” che impedisce di trovare radici a chi dello sradicamento non ha mai fatto esperienza. Chiamare “all’interezza di un corpo frammenti di inaddomesticato” non significa chiamare all’unificazione attraverso un filo dispotico, l’interezza non è unificazione. Credo che leggere insieme questo passaggio sia utile a chiarire meglio ciò che Angela intende:
Noi oggi chiamiamo all’interezza di un corpo frammenti di inaddomesticato, luoghi guerrieri del presente, del mito, della storia, dell’affabulare. Rintracciamo parti e ognuna di queste fa da avvistamento per altre; possiede una completezza essenziale. Ma per raccogliere dobbiamo separare, recidere, staccare da nuove agglomerazioni che tendono a integrarle. In questo la nostra funzione guerriera. Squilibrare dagli insiemi ciò che avvertiamo non ha tenuta. Noi, d’altra parte, riusciamo a vedere solo tenendoci saldamente al nostro frammento di inaddomesticato. Senza questo asteroide sotto i piedi non c’è punto di avvistamento. Avvistare è fare corpo, ma contemporaneamente è tenersi fuori dai corpi, è fare contesto, ma stando fuori dai contesti. Per trovar radici occorre sradicarsi”. (Putino)
Domanda: Esiste, infine, secondo voi, un rapporto fra il concetto espresso da Putino nel primo dei due enunciati – Dobbiamo saper essere straniere senza distanze e vicine senza identificazioni – e il concetto weiliano di “intima estraneità”, cui Angela fa riferimento nel suo libro Simone Weil. Un’intima estraneità?
Paola: Beh, qui si apre un nuovo capitolo al quale, considerata la vastità del tema, dovremmo dedicare, se decidessimo di farlo, altre conversazioni. Direi, a caldo e ormai prossime alla chiusura, che Sì, che esiste senz’altro, a mio parere, un nesso fra il primo enunciato di Angela e la formula di Weil “intima estraneità” se non altro perché nel libro dedicato a Weil, Putino prosegue la critica sui temi già espressi in Amiche mie isteriche. Vediamo infatti che se la parola “estraneità”, contenuta nella formula, rievoca e rimanda alla parola “straniere” contenuta nel primo enunciato, l’attributo “intima”, ad essa riferita, evoca il rifiuto delle distanze (“senza distanze”) contenuto nello stesso enunciato. Ho tuttavia l’impressione che mentre il primo enunciato pone fortemente l’accento sulla relazione fra donne e svolge la funzione – pedagogica, etica, politica e psicanalitica – di indicare la via per impostare un rapporto corretto e salutare fra donne, l’intima estraneità riguardi, prima che la relazione con l’altra/o, la relazione fra Angela e se stessa, la sua necessità di uscire da sé per guardare se stessa e conoscere la verità su di sé. Quella verità che fa paura e alla quale tante femministe hanno preferito sottrarsi preferendo una pseudosoggettività socialmente riconosciuta e inclusa dentro sistemi ideologici rassicuranti e omologanti. La “sventura”, per Putino, consiste proprio in questa inclusione, nella la ricerca di senso e di potere, nella “voglia di vincere”. Da questa trappola occorre uscire e, per farlo, occorre quel “granello di senape” di cui ci parla, attraverso un pensiero imprevisto mosso dall’inconscio che rende consapevoli della prigione in cui rischiamo di marcire.